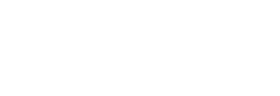Venticinque anni fa a Torino, il 20 giugno del 1993, si apriva di fatto con l’elezione a sindaco del professore Valentino Castellini (già pro rettore del Politecnico) la lunga stagione del centro sinistra. Un potere politico-amministrativo arrivato al capolinea nel 2016, quando il dem Piero Fassino è stato sconfitto al ballottaggio dalla grillina Chiara Appendino.
Ma nell’imminente estate del 1993, l’ingresso in Sala Rossa di un professore universitario d’origine friulana prestato alla politica, noto negli ambienti cattolici, con esperienza nelle Acli e fugaci simpatie socialiste, fu guardato con estremo interesse, come l’ennesimo prodotto del dinamico “laboratorio Torino”. Valentino Castellani, infatti, rappresentava la rottura di antichi schemi a sinistra, dove l’allora partito erede del Pci, il Pds di segretario generale Achille Occhetto, era impegnato nella lunga marcia di uscita dal famoso guado degli anni Settanta e di definitiva trasformazione ideologica che avrebbe dovuto, secondo le migliori intenzioni dello stesso Occhetto, portarlo nelle stanze del potere a palazzo Chigi. Un anno dopo, però, la storia avrebbe avuto uno sviluppo imprevisto con la vittoriosa discesa in campo del cavaliere Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia.
Guardato in retrospettiva, l’esperimento Castellani fu l’epilogo di un controverso processo di gestazione che aveva incrociato la parabola, però in caduta libera, dell’allora segretario torinese del Pds Giorgio Ardito, partigiano di una secca sterzata nelle alleanze a sinistra in prossimità delle elezioni anticipate. Si trattava di una sorta di “Ulivo” ante litteram che Ardito aveva riassunto nella figura di Gian Giacomo Migone, docente universitario dai trascorsi nell’estrema sinistra (Pdup), candidato con il proposito neppure celato di contrastare il ritorno di Diego Novelli, sindaco delle giunte rosse Pci-Psi a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, cofondatore con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando del movimento della Rete.
La candidatura di Migone si sarebbe arenata però con l’eclissi dell’innovatore Giorgio Ardito, dimissionario da segretario provinciale, dopo la sua clamorosa bocciatura dalla direzione del Pds (per volere di Massimo D’Alema, come sostenne il diretto interessato). Eclissi dei nomi, ma non abbandono dell’idea raccolta e rielaborata dal successore di Ardito: Sergio Chiamparino, enfant prodige del Pci negli anni Settanta, prelevato dalla Cgil in cui era stato parcheggiato non senza qualche mal di pancia personale ed esterno.
Chiamparino si ritrovò immediatamente dinanzi bivio del ritorno alle urne prima della naturale scadenza del 1995. Soluzione estrema che si era prefigurava già nell’estate del 1992, quando era emersa in tutta la sua interezza la debolezza della sindaca dell’epoca Giovanna Cattaneo, repubblicana, erede di Valerio Zanone, il sindaco liberale che non aveva resistito alle sirene del Parlamento. Reale o presunta, era stata quella debolezza a creare una serie di incontri tra Dc (partito di maggioranza di una fragile maggioranza di pentapartito) e Pds, tra l’allora segretario della Balena bianca Gian Paolo Zanetta e Sergio Chiamparino, entrambi preoccupati di una crisi al buio per Torino, nel mezzo dell’esplosione di Mani pulite, che avrebbe significato il commissariamento, come di fatto sarebbe avvenuto all’inizio del 1993.
L’ipotesi di una giunta Pds-Dc, in realtà, durò lo spazio di un mattino. Veti incrociati all’interno della Dc che immobilizzarono Zanetta insieme con il secco “niet” di Botteghe Oscure (la storica sede del Pci-Pds) fecero da apripista all’arrivo del commissario prefettizio Riccardo Malpica, nome che a distanza di pochi mesi ritornerà prepotentemente coinvolto nello scandalo dei fondi neri del Sisde.
Da quel momento prende corpo la soluzione Castellani. Ricostruita in maniera schematica è l’alleanza tra una parte della sinistra e la borghesia e i poteri forti della città (che si esprimerà nella lista “Alleanza per Torino”) con in cabina di regia Botteghe Oscure e Chiamparino, quest’ultimo poi premiato con la candidatura, ma non l’elezione (fu battuto da Meluzzi) in Parlamento nel 1994. Il 6 giugno 1993 Torino si divise in tre, tra Diego Novelli, sostenuto da Rifondazione comunista, La Rete, un pezzo dei Verdi, anche loro divisi come la sinistra, e il partito dei Pensionati, Valentino Castellani e la Lega Nord, vero arbitro della situazione, tanto da risultare il primo partito in città con il 23, 35 per cento, ma non da avere il candidato al ballottaggio.
Un “regalo” del celodurista Umberto Bossi che aveva preferito il carneade cuneese Domenico Comino all’autentica anima torinese del Carroccio, Gipo Farassino. Comino si era fermato al 19,50 per cento contro il 20,27 di Castellani, per una differenza di meno di 5 mila voti. Ancora oggi viene da domandarsi il perché di quella scelta suicidaria di Bossi. Errore o favore? Nella seconda ipotesi, nell’interesse di chi? Con Farassino al ballottaggio, Diego Novelli avrebbe probabilmente recuperato la gran parte dei voti della sinistra e con tutta probabilità anche di una parte considerevole del 12,5 per cento dato dai torinesi alla Dc, oltre ai soliti voti in libera uscita.
Ma la storia non si fa con i se e con i ma. Al ballottaggio del 20 giugno Diego Novelli passò dal 36 per cento del primo turno al 42,7 per cento; Castellani dal 20,27 al 57,3 per cento. Il 12 luglio, dopo il parere del Consiglio di Stato sul ricorso di Farassino per il riconteggio dei voti, convocava la giunta comunale. L’inizio di una nuova era politica contrassegnata dal nuovo sistema elettorale certificava definitivamente la divisione a sinistra. Ad un tempo, l’incubatore torinese arrivava a proporre un modello di alleanze che il disastro della “gioiosa macchina da guerra” costruita da Occhetto nel 1994 avrebbe liberato e reso applicabile su scala nazionale con il nome di “Ulivo” da Romano Prodi nel 1996.
La mancata o ritardata evoluzione morale di quel sistema di alleanze e di conseguenza del Paese, complice la disordinata e smisurata lievitazione di ambizioni personali nel centro sinistra, è anche una delle cause che hanno contribuito all’attuale crisi d’identità e confusione del e nel Pd, figlio legittimo dell’Ulivo.
Giugno 1993, nasce il centro sinistra sabaudo