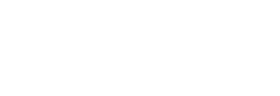Il Partito Democratico è giunto ad un bivio: continuare impassibile ed in stato comatoso sulla strada attuale, nell’attesa che qualcosa succeda (possibilmente agli altri) o imboccare la strada del rinnovamento, inteso non come tanti lo intendono, ma come la gente si aspetta.
L’unico reduce dei partiti del ‘900, inteso come forma organizzativa, è il Partito Democratico.
Un mix tra nostalgici dei riti passati e i fan del personalismo di cui il renzismo (nel senso buono del termine) ne è stato l’apice.
Per un bel po’, in tanti abbiamo creduto che le due grandi anime potessero coesistere.
Non abbiamo capito in tempo che invece si rischiava l’implosione.
La vulgata comune, però, tende ad esasperare la situazione attribuendo allo stesso PD le colpe di una crisi che in realtà ha radici ben più lontane nel tempo e travalica i confini italici riguardando tutti i partiti della sinistra europea.
In questo contesto le dinamiche congressuali non aiutano a rendere più chiaro e semplice il quadro,anzi.
In un contesto politico come quello attuale, la burocrazia congressuale è un fatto del tutto incomprensibile per chi il PD non lo vive dall’interno e perfino per chi, invece, lo frequenta. Una macchina dunque complessa, che non da ora ha i suoi limiti. Dopo il 4 marzo, i problemi strutturali sono venuti fuori in maniera solo molto più evidente, ma esistevano anche nel Partito del 40,8%.
Man mano che il tesseramento si è fatto più piccolo, una fetta dello stesso Partito ed anche qualche intellettuale, più che porsi il problema di come rilanciare il PD ha puntato il dito verso chi ancora quel tesseramento lo ha stimolato. E così, invece di suonare i campanelli delle case di coloro che non intendevano più rinnovare la propria adesione, invece di spiegare loro i motivi per i quali sarebbe stato ancora giusto credere in un progetto aderendovi, hanno preferito dormire sugli allori e prendersela con chi, invece, ha continuato a stimolare l’adesione appellandoli pure in modo dispregiativo come “Signori delle tessere”.
Per non parlare di coloro che puntano spesso il dito per la chiusura delle sedi, senza però indicare il modo concreto con cui i Circoli possono, invece, essere messi nella condizione di sopravvivere. Nella mia mente li ho sempre immaginati come “Dirigenti da reality”, ossia quelli che dal divano di casa osservano, giudicano, seguono in silenzio e poi ad un certo punto sentenziano chi debba uscire dal gioco o rimanerci.
Ma vediamo come funziona un Congresso.
Gli iscritti saranno chiamati ad esprimersi sulle “mozioni” dal 7 al 23 gennaio all’interno di “convenzioni” di circolo. In base ad un sistema di attribuzione numerica cervellotico, ogni circolo dovrà eleggere i propri delegati in una “convenzione” provinciale. Questa, da svolgersi dopo il 23 gennaio, dovrà eleggere i delegati attribuiti nella convenzione nazionale che decreterà, ufficialmente, coloro che il 3 marzo dovranno sfidarsi alle primarie. Quindi, le “convenzioni” non sono altro che organismi provvisori inseriti nel meccanismo congressuale e niente più.
Tutta questa procedura ovviamente è seguita dalla supervisione di commissioni congresso varie, raccolte di firme tra gli iscritti per le candidature ed altre incombenze burocratiche.
Ora, la domanda che si pongono i più è: può un Partito avere le stesse dinamiche procedurali, le stesse strutture, la stessa forma organizzativa che aveva un Partito con centinaia di migliaia di iscritti in più?
E non solo.
L’assemblea nazionale è composta da circa 1400 persone, tra membri eletti, invitati ed altri.
La direzione nazionale da 214 persone. L’assemblea regionale, ad esempio del Piemonte, è di circa 400 persone, la direzione da circa 80 più gli invitati permanenti.
L’assemblea provinciale, ad esempio Torino, è composta da circa 260 persone più invitati, la direzione da circa 70 membri.
E non è finita qui. Ogni circolo ha il suo mini parlamentino di oltre 20 persone a seconda del territorio rappresentato e del numero di iscritti.
Alle assemblee, alle direzioni, si aggiungono ovviamente gli organi esecutivi (le segreterie).
Dunque una babele di procedure e di organismi, che mentre in epoche più felici garantivano un certo grado di democrazia interna e rappresentatività del pluralismo, ora sembrano quantomeno non in linea con i tempi della Politica e con l’esigenza di sintesi ed immediatezza delle decisioni e delle proposte.
Nessuno, sia ben inteso, ha avuto mai il coraggio di affrontare seriamente la questione della forma Partito. Siamo sempre arrivati al punto di modificare lo Statuto, ma quando si è arrivati al dunque lo si è fatto più per risolvere in corsa esigenze momentanee che per riformare sul serio la nostra forma organizzativa, che, diciamolo, non è più al passo coi tempi imposti dalla Politica e dalla società odierna.
Non si è dunque capito che è la società che cambia i Partiti e non il contrario.
Nonostante ciò è lodevole, direi eroica, qualunque iniziativa in grado di ravvivare i circoli, di trasformarli in luoghi ove non necessariamente viene solo consumata la burocrazia interna, ma ci si apre all’esterno.
E’ altrettanto positivo l’approccio con il quale, quantomeno a Torino, il PD abbia ripreso a dialogare con alcuni mondi che ci avevano abbandonato e sta puntando a risvegliare l’orgoglio di una comunità tramortita dopo le sconfitte elettorali.
Ma non basta.
Quello che più è demoralizzante, è non avere la certezza che il Congresso sia occasione, una volta per tutte, per dirimere tutte le questioni finora elencate.
Certo non è nascondendo la polvere sotto il tappeto, né rimandando ulteriormente i punti dirimenti che potremo uscire da quelle che sembrano delle pericolose sabbie mobili.
Spero dunque che i candidati alla Segreteria battano un colpo anche su questo, anziché concentrarsi se il PD debba aprirsi più verso il M5S o verso Forza Italia o ribadire l’illusione della vocazione maggioritaria. Oppure se seguire Macron o Corbyn o Sanchez. Sia un Congresso che si occupi in primis cosa debba essere il PD, poi del resto sarà più facile occuparsene.
Partito Democratico: i congressi e il costo della democrazia interna