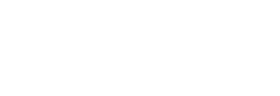Scritto da Sara Collicelli
Eh si, ragazzi. Ci vuole davvero metodo per tutto. Per lavorare, per studiare, per cucinare. Per vivere. Serve un metodo. Nessuno ci insegna quello giusto, forse perché non c’è. Forse perché chi lo ha trovato non vuole condividerlo con noi comuni mortali. Chissà. Chi vivrà vedrà.
Ma il punto è proprio questo. Chi vivrà?
Vivrà chi avrà capito il metodo? E come si fa a capire quale sia?
Sono tutte domande esistenziali che mi arrivano dopo aver visto la nuova serie targata Netflix.
Il 16 novembre, infatti è uscito The Kominsky Method – Il metodo Kominsky. Dalla sagace mente di Chuch Lorre (per intenderci, lo stesso di The Big Bang Theory) questa serie vede il ritorno di un Michael Douglas invecchiato ma che mantiene il suo fascino e un dolce, dolcissimo Alan Arkin, il delizioso nonno di Little Miss Sunshine.
La serie, che indubbiamente ricorda moltissimo un’altra produzione Netflix, narra di due amici, Sandy Kominsky e Norman Newlender. Il primo è un attore che un tempo vide la fama e ora gestisce insieme alla figlia una scuola di recitazione, mentre il secondo è il suo agente nonché il suo più vecchio e caro amico.
Un’amicizia che ha visto il tempo scorrere, innumerevoli matrimoni di Sandy fallire, la figlia di Norman entrare e uscire dalle cliniche di disintossicazione come noi entriamo e usciamo dagli ascensori. Ha visto una carriera scorrere verso il declino per riciclarsi laddove poteva.
Ma soprattutto vede, in apertura della serie, un grave gravissimo lutto colpire Norman. Siamo praticamente subito invitati al funerale della moglie di Norman. Il suo grande amore, la sua vita. Non credo sia necessario raccontare cosa possa comportare un lutto del genere dopo quarantasette anni di matrimonio.
E pochi giorni dopo il funerale saremo invitati a una paradossalmente spassosa visita urologica del nostro Sandy, che scoprirà poi di avere un problema importante alla prostata.
Tra battute di spirito che si scambiano i due amici, di ritorno dal viaggio per accompagnare la figlia di Norman al suo ennesimo ricovero per disintossicarsi, c’è una profonda e malinconica riflessione sulla vita.
Perché capita a tutti, prima o poi, di interrogarsi sullo scopo della propria vita. E se ti crolla il mondo addosso pensi che sia inutile. Ma chi ha deciso cosa è utile e cosa è inutile? Di certo, non noi. Perché tutto è utile e niente lo è.
E forse, più che utile risulta vincente il metodo di Sandy. Il metodo Kominsky. Che vede il suo più vecchio e caro amico crollare, perdere i pezzi, vittima di un dolore indescrivibile e sta al suo fianco. Sempre e comunque.
Nasconde a tutti la sua malattia, dice “sto bene… devo solo prendere qualche medicina”. Nasconde la fine di una relazione appena iniziata che lo coinvolgeva molto.
Nasconde la sua di paura e sofferenza e accosta la macchina per dire al suo amico “tu non sei solo. Hai me.”.
Quante volte è capitato di non sentirsi visti dalle persone? Ma visti davvero. Visti nella nostra debolezza, nella nostra fragilità.
Questo fa Sandy, questo è il metodo Kominsky. Vede Norman. E gli dice “non preoccuparti se tu non riesci a vederti. Ti vedo io.”.
Non esistono gerarchie nella scala del dolore, sia chiaro. Esiste altro, che definire mi è impossibile. Esiste la capacità di riconoscere che non sempre le cose vanno come dovrebbero. O come noi vorremmo andassero.
Ma la ricetta che mi sembra più opportuna è quella che ci insegna Sandy Kominsky.
Fermarsi, accostare la macchina, e agitare la mano di fronte al viso estraniato di chi per noi è tutto. Agitare la mano e dire “Io ti vedo. Io sono qui.”.
Perché, forse, esserci, è il vero metodo per vivere.
Kominsky: perché alla fine dei conti è tutta questione di metodo