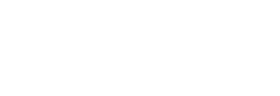Dorothy Lichtenstein, vedova del celebre Roy, si aggira tra le opere del marito, inseguita da un gruppetto di fotografi dopo essere intervenuta alla conferenza stampa per Roy Lichtenstein. Opera prima, in programma alla GAM fino al 25 gennaio, dove Danilo Eccher (direttore della Galleria e curatore dell’esposizione) ha risposto così alla domanda di un giornalista: “La Pop Art, di cui Lichtenstein è stato un rappresentante d’eccezione, ha realizzato le allusioni dell’avanguardia sulla fine dell’arte come affermazione della vita”. Dichiarazione oscura, almeno se si pensa che a farla è chi ha selezionato, per la galleria d’arte che dirige – con l’aiuto di Dorothy e della sua Fondazione – 235 opere dell’artista newyorkese, messe in mostra per migliaia di visitatori.
Fine dell’arte? Andiamo con ordine. Nato nel 1923, Lichtenstein salì agli onori della cronaca quando, nel 1962, una serie di sue opere raffiguranti immagini tratte da fumetti, o oggetti di uso comune, fu venduta a un ritmo frenetico, in poche ore, prima ancora che l’esposizione organizzata alla Leo Castelli Gallery di Manhattan avesse inizio. Esplodeva la Pop Art: Andy Warhol esponeva le sue celeberrime fotografie, sei anni dopo la bandiera a stelle e strisce di Jaspers Jonhs, mentre James Rosenquist completava il suo aereo da guerra. Onomatopee colorate, barattoli di ketchup e scatole di detersivo: Lichtenstein e Warhol, principi del genere, produssero un mondo di opere che ritraeva quello industriale, quello delle merci e del gusto popolare che popola i sentieri profani di ciò che – bello o brutto che sia – non è (considerato) arte.
Ciò che caratterizzò l’opera di Lichtenstein, in particolare, fu il piano bidimensionale, che lo accomunò, diversamente da Warhol, ai pionieri astratti dell’action painting, che avevano percorso tutt’altre strade pochi anni prima. L’astrazione non era per lui, d’altra parte, una sconosciuta: proprio in mostra alla GAM troviamo una composizione del 1974 che si risolve in un mero accostamento di colori primari, o le Entablatures del 1971-1975, oltre a una testa “picassiana” del 1984. “Ho dipinto fumetti e puntini per soli due anni. Possibile che nessuno si sia accorto che ho fatto altro?”; non stupisce, allora, che oltre a una serigrafia su carta come Sweet dreams, baby!, tipica del suo più celebre atteggiamento espressivo, o agli studi per opere conosciutissime come Pop! (1966) o Oh, Jeff… I love you too… But… (1964), si trovino in questo allestimento divagazioni tarde, e meno note, sul nudo femminile (1993-1996, pur sempre in un sensualissimo stile fumettistico), o una tavola dove il puntinato Ben-Day apre a una suggestione vagamente cupa, a suo modo misteriosa (Landscape With Boat, 1996).
È pochi metri oltre l’ingresso, tuttavia, che ci imbattiamo in Cup of Coffee e Zipper (1962), Ice Cream Cone e Bread and Jam (1963): gelati, tazze di caffè, fette con la marmellata e comode zip ritratte con sofisticata semplicità e una stilizzazione bonaria, divertita, che ancora allude al fumetto, pur non riproducendolo direttamente. Isola enti e momenti dell’ordinario e del banale, trasfigurati in oggetti d’interesse estetico ben più che antropologico o culturale; ed ecco che Eccher vi sottolinea l’uso del retino tipografico, “allusione alla riproducibilità tecnica”. La dimensione ordinaria delle cose fa i conti con la serialità del prodotto industriale e si misura, secondo il curatore, con i “timori” di Walter Benjamin, sebbene per Benjamin la serialità, e il tendenziale assassinio della nozione di originale, fossero tutt’altro che associate al timore, semmai all’auspicio – là dove la perdita di “autenticità” del mondo industriale avrebbe aperto potenzialmente un inedito percorso di liberazione estetica, sociale ed espressiva.
Se le opere Pop furono sue postume alleate, allora, fu ove seppero riconoscere che l’apprezzamento estetico non ha luogo al di fuori dell’esistenza, che per definizione è quotidiana; quotidianità che, ai giorni nostri (e a quelli di Benjamin) è concretamente industriale, là dove l’industria andrebbe concepita con sguardo fortemente contemporaneo, come ingranaggio metropolitano di produzione e consumo. Merci da supermercato, cose alla mano (ieri barattoli o fumetti, oggi automobili o smartphone) sono sempre valutati esteticamente da chi li compra, nel bene o nel male, come da chi non li ha. Il privilegio estetico assegnato all’arte appare allora, in effetti, un residuo della reverenza religiosa che si può provare per la reliquia di un santo, là dove è il tocco di una personalità scomparsa (imparentata, come il genio artistico, con il divino) a giustificare la nostra attenzione, la nostra visita, il nostro fervore. L’irruzione della riproduzione tecnica e del design ha messo in crisi questa sorta di superstizione, che è rimasta in vita nelle riserve indiane del lusso mercantile o del commento erudito – o ancora (più modernamente) come settore specifico dell’industria culturale.
Ne sono prova, se ce ne fosse bisogno, le parole del sindaco all’inaugurazione: “La cultura non è qualcosa che si aggiunge allo sviluppo economico, ma ne è fattore costitutivo”. Cultura come industria, arte come suo settore: Opera prima è costata 800.000 euro, il break even point per rientrare nelle spese è 70.000 visitatori, e per questo un complesso dispositivo di marketing e advertising fa da sponda a questo come ad altri “eventi”. I giornalisti in sala assediano, e indispettiscono, la presidente di Fondazione Musei con una caterva di domande su dati finanziari e sponsor, che infine lei liquida, stizzita, come “contabilità”. Eppure lei stessa usa a piene mani il tono acritico dello spot, quello che si usa per piazzare un prodotto. Aura e società dei consumi, a ottant’anni da Benjamin, si sono rivelate perfettamente compatibili, e più grazie a simili gallerie a pagamento e al sistema di eventi correlato che alle aste miliardarie di Sotheby’s.
Lo mostra il fatto che, a mezzo secolo dalle dissacrazioni di Whaam! o Drowning Girl, sono gli schizzi di prima mano tratti dai taccuini dell’artista a costituire fattore di attrazione per il pubblico. L’idolatria del tocco autoriale è dura a morire, ed è anche vero che la Pop Art ha meramente raffigurato, e non incarnato, la cifra riproducibile, e perciò esteticamente satanica, dell’età industriale – possibile fattore di decostruzione del fenomeno auratico. L’ha sospesa, esorcizzata e puntualmente neutralizzata nel processo di grande copiatura delle sue forme, o nel ready made di seconda generazione, tentando con successo il salvataggio in extremis del residuo auratico anche dove non c’era, in una curiosa, doppia trasfigurazione – mettendolo in mostra. Si è vendicata così, in realtà, sull’industria facendone copia, mostrando la capacità dell’artista di sopravvivere alla propria fine (logica) come figura sociale.
Il lutto ipocrita che continuamente e gioiosamente elaborano le istituzioni artistiche è, allora, puramente filosofico: se “fine” c’è stata, si è trattato del compimento di un processo di saturazione della discernibilità estetica di opera e mondo, che si è fatto strada nei secoli ed è culminato nel ready made in forma più o meno spuria, scardinando sul piano concettuale uno dei capisaldi dell’arte tradizionale: l’imitazione. Sul piano extraconcettuale, invece (dove si situano, in modo diverso, tanto la sorgente bruta dell’economia quanto l’estetica) la raffigurazione operata dalla Pop Art, nei fatti mimetica, del prodotto industriale (sia pur nell’artificio di una copia falsamente perfetta, su cui ancora oggi lavorano gli avvocati per opporsi alle richieste di royalties: Dorothy ne sa qualcosa) resta pienamente entro il perimetro tradizionale del gioco artistico e, in questo modo, ne rafforza e innova l’ideologia.
La contraddizione tra arte e vita – tra sfera creativa ideologicamente disciplinata e piacere concreto, ignaro di tale disciplina – era quindi certo stata additata dalle avanguardie di inizio secolo, ma senza conseguenze decisive sul piano sociale. Il Pop da galleria di molti anni dopo fu quindi, paradossalmente, la rappresentazione trionfale, più o meno volontaria, della capacità di sopravvivenza della sfera specifica che chiamiamo arte. Essa sopravvisse al doppio assalto del tentativo avanguardista di metterne in discussione senso e confini – quel che fece più paura, dall’interno – e della sfida estetica portata dalla produzione industriale, con la beffarda esposizione di questa doppia contestazione. Danno collaterale? Un intero ceto di critici e accademici che, sulla narrazione di come l’arte morì, sopravvivono a loro volta. Il mondo in cui qualcosa (la Pop Art, o altro) avrebbe realizzato l’avanguardia, è quindi squisitamente immaginario. In esso né questa mostra su Lichtenstein, né la GAM o il suo direttore – facciamoci caso – sarebbero mai esistiti.