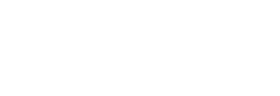I mormorii in sala si spengono in pochi secondi, quando il pubblico si accorge di non essere più solo. Una donna anziana, dallo sguardo dolente, ci osserva dal palco, le luci ancora accese. La tragedia sorge come dal reale, prima che ce ne possiamo accorgere, senza lo stacco formale che le regole non scritte imporrebbero per tracciare la separazione percettibile tra vero e falso, realtà e finzione. Siamo allora portati a immergerci dolcemente, ma terribilmente, nella condizione di cui le attrici del collettivo Mitipretese si fanno interpreti: la guerra. O meglio: the aftermath; le conseguenze di un massacro.
Troia è distrutta, i suoi abitanti decimati; quattro donne, rimaste vedove, lamentano l’avversità del loro destino. Non sono donne qualsiasi: Elena, Cassandra e Andromaca toccano una montagna di vestiti per metterli in piega, sullo sfondo, rinchiuse nel ruolo che una società antica come quella moderna ha loro cucito addosso. La signora anziana – Ecuba – siede alla loro destra quando prendono posizione sulla scena, secondo un’organizzazione degli spazi e della geometria scenica ineccepibile dall’inizio alla fine della rappresentazione (le luci e la scenografia sono di Mauro De Santis, la regia è del collettivo di attrici).
L’offesa della violenza carnale già subita è restituita da una cantilena mesta, dall’intonazione rassegnata: lo stupro è, in guerra, da sempre suggello della presa di possesso del territorio umano, vivente, che nell’umiliazione femminile allude al potere supremo sulla società – quello della riproduzione. Gianna Giachetti (Ecuba) grida, sibila, sussurra con grande maestria scenica le conseguenze dell’atroce schiavitù, usando una vasta tonalità espressiva, particolarmente incisiva quando la voce si fa penetrante e si rende simile al gemito, più che quando ingrossa il proprio volume. Andromaca (Mariàngeles Torres) dialoga, si muove e consola, sa che sarà data in moglie al figlio dell’assassino del marito, Neottolemo, che fu partorito dal seme di Achille. Viene a sapere da Elena che anche suo figlio è stato giustiziato, poiché l’assemblea dei Greci ha approvato il parere di Ulisse: il figlio di Ettore non può sopravvivere, neanche come prigioniero, poiché la sua stirpe potrebbe mettere in pericolo la pace dei Greci in futuro, costruendo la vendetta di cui Cassandra si fa sinistramente e meravigliosamente auspice.
La notizia della condanna a morte del piccolo Astianatte è il momento forse meno riuscito della rappresentazione: la tensione drammatica non raggiunge un’intensità adeguata all’orrore che si propaga tra le protagoniste (la scena dell’assassinio, invece, è narrata sostituendo ai versi di Euripide – come in altre parti dell’opera – quelli non meno celebri, dal gusto macabro e decadente, di Seneca). Andromaca è consolata da Cassandra (Manuela Mandracchia), la veggente che non si arrende al destino; proprio lei, che ne vede in anticipo i segni, soffre gli spasmi epilettici di una rabbia che non si accontenta degli angusti confini della norma mentale, non lesinando al pubblico picchi di interpretazione. La sacerdotessa accusa, il volto deformato dall’odio e dalla disperazione, poi ride in modo sinistro: progetta l’omicidio del capo dei nemici Agamennone che, con intento blasfemo, l’ha scelta come concubina. Piange, grida, tace sgomenta, il corpo continuamente prostrato o scosso da traumi che l’essere umano da sempre sopporta, pur non potendo sopportare.
Manuela Mandracchia alza il grido di ribellione dell’umanità, anzitutto femminile; ma è Sandra Toffolatti a interpretare il personaggio più coinvolgente perché psicologicamente più obliquo: Elena. Accusata dalle altre tre di essere origine e causa della guerra e delle sue conseguenze disastrose, etichettata come infame e puttana, si ribella (con coraggio? Indecentemente?) al peso di un simile fardello, ora attirando la nostra comprensione, ora la nostra ripugnanza. È forse lei il ricettacolo tragico più oscuro e disturbante dell’opera. Può una sola donna essere considerata origine di dieci anni di guerra tra una città asiatica e la Grecia intera? Vestita di abiti sensuali, disegnati da Cristina Da Rold, Elena si rivolge alla platea e spiega la propria innocenza. Afrodite, la Dea, offrì il suo corpo a Paride come premio. Come avrebbe potuto, grida a Ecuba, resistere alle trame di una divinità così potente?
La regina non si lascia impressionare: questa forza impersonale, il divino/destino, che gli umani chiamano in causa per spiegare le proprie malefatte, altro non è che il vile tentativo di fuggire le proprie responsabilità (“Non ero io”, dice di sé Elena, commentando la propria fuga adultera con Paride). Sono l’amore, l’adulazione, l’egoismo e il desiderio i motori che vorremmo alienare nella figura trascendente del divino: ma alle forze che tentano di governare i nostri sensi e la nostra mente siamo tenuti a resistere, se lo richiede una responsabilità sociale. Ecuba accusa e insulta Elena, finché la donna viene percossa e picchiata selvaggiamente da Andromaca e Cassandra, torturata mentre geme rantolante, implorando aiuto.
Violenza di donne su donne, in seguito alla violenza degli uomini: qui le attrici/registe riescono a cogliere ed esprimere in modo intelligente il senso profondo della tragedia di Euripide. Le donne cantano il loro dolore e la loro rabbia. La contingenza del fatto è mera testa di ponte per aggredire una condizione politica, umana, sociale che è universale, come negli scopi del teatro greco (e della poesia in genere) secondo Aristotele. Tutto il gioco narrativo è incentrato sull’evidenza dell’ingiustizia che le donne patiscono in guerra, là dove quest’ultima è l’evento politico che getta luce sulle contraddizioni che già riposano o si rivelano in tempo di pace. Eppure la tragedia dell’oppressione femminile concreta non è, nella rappresentazione che va in scena al Gobetti, un lago in cui ogni donna possa specchiarsi senza increspature. Perché?
Anche le donne hanno ruoli, responsabilità, privilegi concessi o conquistati. Elena è lì, ora nella parte della fredda messaggera dei vincitori – traditrice due volte, due volte infame – ora in quella della vittima accusata, insultata, percossa per atti che soltanto degli uomini hanno compiuto. Ora appare una donna meschina e calcolatrice, pronta a tornare tra le braccia di Menelao, ora incarna e raffigura il corpo femminile da sempre capro espiatorio per le oscenità che i maschi progettano, compiono, giustificano. È un fuscello sbattuto tra l’Ellade e l’Anatolia dai venti del destino olimpico o dalla condizione femminile e umana, ma anche, innegabilmente, una persona dotata di arbitrio che sceglie di volta in volta la parte del vincitore, che collabora con l’oppressore pur pretendendo di dissociarsi dagli effetti delle sue nefandezze.
Mitipretese si tiene lontana dalla retorica e dal cattivo gusto di ogni morale che si voglia estrarre in modo immediato, unilaterale, come un coniglio dal cilindro dell’evidente o dell’ovvio, nell’attesa pigra di un consenso sociale garantito; eppure non rinuncia a prendere posizione, facendolo in modo grandangolare e complesso. Il senso profondo e (per nulla paradossalmente) moderno dell’opera appare alle attrici come un obiettivo da conquistare a costo dello sforzo, con quasi due ore di spettacolo sofferto, vissuto, palesemente pensato e ripensato. Accade così che quando le quattro intonano lentamente un’aria conosciuta, familiare, che cresce nel silenzio del teatro fino a rivelarsi come il vecchio inno dell’Unione Sovietica, la forzatura espressiva si fa largo nello spazio alto della sala in modo talmente rispettoso e delicato da apparire legittima, e stimola suggestioni anche in chi è scettico verso qualsiasi accostamento che voglia remare nel torbido dell’eclatante e del magniloquente, o del fintamente meditato. Un fatto raro, a teatro.
Le Troiane resta, dal canto suo, un’opera profondamente inattuale. Tentano di abituarci a guerre dove il nemico, pur non detto esplicitamente barbaros, è squalificato sul piano umano, prima ancora che su quello linguistico, politico o dell’antagonismo economico; negato antropologicamente quale demonio invisibile, senza cultura di sorta, ragioni o dignità – elemento inspiegabile, alieno o marziano – forza cieca, terrorista. Questa squalifica ontologica ha luogo, anzitutto, proprio sul piano della rappresentazione, dalla televisione al cinema. Euripide viaggiò su altri canali. Offrì al suo pubblico, ventiquattro secoli fa, le sofferenze e il dramma delle donne della città nemica, sulla cui distruzione si era fondato il mito politico della sua gente, della koiné di autore e drammaturgo cui apparteneva; ne tradusse in versi le invettive rivolte alla brutalità della Grecia. Eppure Euripide, oggi, è un grande anche per chi vive sulla produzione di scrittura o immagine che legittimano in mille forme l’annichilazione del nemico o la guerra stessa. Misteri di questa “cultura” neutra e intatta da cui siamo perseguitati al plasma al silicio al cinema o al teatro o per strada, dove nulla conserva l’ambiguità di Elena, e dove tutto affoga senza gli spasmi di Cassandra.
©Copyright 2021 AGM service Soc. Coop.
P.I. 11758400011
Redazione Nuova Società
Via San Quintino 1 3 - 10123 - Torino, Italia
011 2170360
redazione@nuovasocieta.it
amministrazione@agmservice.it
Registrata al Tribunale di Torino n. cronol. 5135/2017 del 15/12/2017, Rg n.15443/2017.