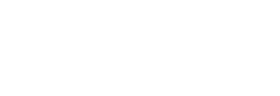Scritto da Gabriele Richetti
C’è stato un tempo in cui i torinesi passavano poco volentieri da via Bonelli (già via Fornelletti), una piccola via nel cuore del quadrilatero romano. Fino agli inizi del ‘900 al civico numero 2 della via abitava infatti un cittadino molto particolare, una figura necessaria all’applicazione della “giustizia” del tempo e perciò temuta da tutti. Il boia.
A Torino, dove la tradizione degli esecutori di giustizia è stata sicuramente tra le più importanti in Italia, il boia più famoso (nonché l’ultimo) fu Pietro Pantoni.
Pantoni, per sua sfortuna, veniva da una famiglia di boia: il padre Antonio era stato esecutore per lo Stato Pontificio, il fratello Giuseppe era boia a Parma. La sua strada era segnata fin dall’adolescenza: nel 1831, Pietro riceve da Urbano Rattazzi la patente di Ministro di Giustizia torinese. Rimarrà in attività per più di trent’anni, giustiziando 127 persone, fino al 13 aprile 1864, anno in cui si toglierà il celebre e sinistro mantello rosso: la forca avrebbe da lì in avanti lasciato il passo alla fucilazione.
Il boia ispirò il pancarrè
La figura del boia, ovviamente, era denigrata da tutti. La moglie di Pietro Pantoni soffrì particolarmente questa situazione e si dice che non uscisse mai di casa: l’abitazione dell’ultimo boia, raccontano le testimonianze, era la più pulita dell’intera città.
D’altro canto, già nel XV secolo il duca Amedeo VIII di Savoia era intervenuto per riportare l’ordine tra i fornai della città di Torino, che si rifiutavano di vendere il pane al boia. Il duca li obbligò a farlo, pena il diventare clienti dello stesso esecutore. Ma i fornai, astuti, escogitarono un modo per manifestare comunque il loro disprezzo e iniziarono a porgere alla moglie del boia il pane al contrario. Il Duca intervenne di nuovo: nacque il pancarrè, un pane uguale dai due lati, per non far torto a nessuno. Nonostante tutto, le monete pagate dalle consorti dei boia torinesi continuarono ad essere gettate in una ciotola di aceto dai fornai, per essere “ripulite” dalla loro efferata origine.

Curioso era anche il metodo con cui il boia veniva pagato dopo un’esecuzione. Il responsabile firmava il foglio di pagamento indossando i guanti, per non aver nulla a che fare con quel denaro. Dopodiché buttava il foglio per terra, dove un addetto lo prendeva con delle pinze e lo gettava al boia, che aspettava nella tromba delle scale o sotto la finestra.
Certo, l’esecutore di giustizia torinese aveva anche piccoli privilegi: un banco riservato nella Chiesa di Sant’Agostino e il diritto ad essere sepolto sotto il campanile di quella stessa Chiesa.
Il tragitto verso il patibolo
Il tragitto dei condannati ci è noto grazie all’opera di San Giuseppe Cafasso, il “prete della forca” torinese, che, oltre ad essere stato per anni accanto ai condannati negli ultimi istanti di vita, ebbe anche l’incarico di celebrare il matrimonio di Pietro Pantoni nel 1846.
Il lungo e macabro iter cominciava la sera prima dell’esecuzione, quando Cafasso, il condannato e il boia si riunivano per pregare. Durante la preghiera, il boia chiedeva perdono al condannato per ciò che avrebbe fatto il giorno successivo. All’alba, dal confortatorio del carcere, il condannato saliva sul carro che lo avrebbe condotto al patibolo, scortato dai membri della Confraternita della Misericordia, incappucciati, che recitavano il Miserere, mitigandone la sofferenza, visti i ripetuti oltraggi della folla e dello stesso boia, che saliva sul carretto con il morituro.
Davanti agli occhi del condannato, al cui collo veniva messa una corda precedentemente benedetta, veniva posto un grosso crocifisso dotato di alette laterali, così che lo sfortunato vedesse il patibolo soltanto all’ultimo momento. Questo crocifisso è conservato ancora oggi nella Chiesa della Misericordia a Torino.
L’esecuzione e le macabre superstizioni ad essa legate
L’esecuzione stessa era una sorta di spettacolo teatrale, al quale la folla accorreva numerosa. Il boia doveva rispettare il condannato, concedendogli gli ultimi riti che gli spettavano, tra cui quello di baciare il crocifisso e di richiedere l’ultimo pasto, generalmente una scodella di minestra (al brod d’ôndes ôre, visto che le esecuzioni spesso erano alle 11 della mattina). Doveva inoltre essere rapido nell’esecuzione e abile nel portarla a termine (non mancavano i casi di impiccati non completamente morti o dall’agonia terribilmente prolungata). Se il boia veniva meno ad uno di questi doveri, la folla, ad esecuzione conclusa, invece di applaudirlo lo insultava, colpendolo con pietre e altri strumenti.
Per evitare queste situazioni, il boia, quando l’impiccagione andava per le lunghe, si faceva aiutare dai tirapiè, due aiutanti che tiravano il condannato per le gambe mentre il boia stesso gli saltava sulle spalle per accelerarne la morte. Il corpo era poi trasportato nel cimitero torinese di San Pietro in Vincoli, oggi in disuso.
Ad esecuzione conclusa, un ultimo compito spettava al boia e ai membri della Confraternita della Misericordia: evitare che la folla si gettasse sugli strumenti usati dall’esecutore e persino sul corpo del condannato. Tanti credevano infatti che il grasso di un impiccato curasse i malanni (alcuni boia torinese precedenti a Pantoni, come il famigerato Gaspare “Gasprin” Savassa, addirittura ne avevano tratto un commercio) e che la corda usata per l’impiccagione portasse fortuna per il gioco del lotto.
Ricco come un professore universitario
Per quanto riguarda il salario, nel 1800, quindi all’epoca di Pietro Pantoni, il tariffario ufficiale per le esecuzioni prevedeva un compenso di 16 lire per un rogo, 21 lire per un’impiccagione e addirittura 36 lire per uno squartamento. Erano cifre molto alte. Basti pensare che un boia guadagnava all’anno il triplo di un tessitore o di un maestro, il doppio di un panettiere. La stessa cifra di un professore universitario.


Anche il boia, in ogni caso, era un uomo come gli altri. In fondo si trattava pur sempre di un funzionario pubblico. Nella lettera qui sotto, Pietro Pantoni chiede il differimento di una esecuzione, sentendosi debole a causa di una indisposizione:
“Illustrissimo Benigno Signoria Avvocato Fiscale Generale, l’umilissimo Pietro Pantoni, capo esecutore di giustizia ha l’onore di osservare alla Signoria Vostra che per certe picciole sanitarie indisposizioni, cioè dissenteria, e l’umile esponente non trovandiosi concentrato nelle proprie forze non puole disporre nell’attuale seguente esecuzione, perchè debole, epperciò umilmente chiede una dilazione di quattro o sei giorni, che della somma grazia l’umilissimo supplicante, Pietro Pantoni”.
Fa sorridere, da ultimo, ciò che Pietro Pantoni chiese ai superiori nel 1852 e nel 1853. Resosi conto che l’impiccagione era ormai un metodo anacronistico e di grossa sofferenza per i condannati, il boia torinese chiese la possibilità di passare alla ghigliottina “per umanità dei poveri pazienti”.