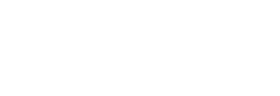Ammettiamolo. In questo mondo impazzito ci sono cose più serie di cui occuparsi e preoccuparsi. Però faccio il giornalista, e continuo a pensare che le sorti del nostro mestiere siano di qualche interesse non soltanto per noi, ma anche per tutti gli altri, perché non esiste democrazia senza una informazione di qualità, distinta dal bombardamento di marchette variamente dissimulate cui siamo quotidianamente sottoposti.
I giornalisti dovrebbero essere i primi a preoccuparsi della confusione tra informazione e comunicazione che regna sovrana in rete, dove tutti possono dire tutto e il contrario di tutto, e anche nella carta stampata, nelle radio e nelle televisioni, dove qualche regola, almeno in teoria, esiste. Dovrebbero farlo, se non per spirito civico, almeno per difendere le proprie prerogative e la pagnotta: negli ultimi anni il crollo parallelo del prestigio e delle retribuzioni della categoria ha dimostrato che non servono professionisti lautamente pagati per copiare i comunicati stampa, reggere il microfono del potente di turno, e ripetere a pappagallo le dubbie verità del pensiero unico che vuole ridisegnare la società per metterla al servizio del mercato globale.
Invece l’ordine del giornalisti, l’organismo che raccoglie e rappresenta tutti i giornalisti italiani, non sembra particolarmente preoccupato. E’ un pachiderma appesantito dagli anni e da una legge che consente l’accesso a chiunque abbia scritto una breve sul più infimo dei bollettini, o anche semplicemente maneggi qualche documento vagamente assimilabile a una notizia. Fecero storia i solerti impiegati di un importante ente pubblico piemontese che per il solo fatto di ritagliare i giornali della rassegna stampa furono mandati in massa a sostenere l’esame professionale, e da un giorno all’altro diventarono colleghi.
Tra professionisti e pubblicisti gli iscritti all’ordine sono oltre 110 mila, uno ogni 550 italiani, e basterebbe la cifra per capire che qualcosa non va. Se poi consideriamo che meno della metà degli iscritti ha il requisito minimo di una posizione aperta con la cassa previdenziale di categoria, appare evidente la difficoltà di conciliare gli interessi di chi davvero vive di giornalismo con quelli, legittimi ma diversi, di chi nella vita fa tutt’altro. Aggiungiamo a tutto questo il folle meccanismo elettorale che nel corso degli anni ha fatto crescere la rappresentanza dei secondi negli organismi dirigenti, e il piatto è servito.
Un ordine in queste condizioni non poteva che essere preso d’assalto da arrivisti, pensionati frustrati e qualche avventuriero. Incapace di agire perché paralizzato dalle contraddizioni, ha dedicato tutte le sue energie a conservare se stesso e i suoi privilegi, resistendo con camaleontica abilità a ogni tentativo di cambiare le cose. Inutile da sempre, grazie a una leggina varata da un precedente governo è diventato negli ultimi tempi anche molesto, perché non si limita a riscuotere da ogni iscritto la tassa annuale, ma pretende anche di imporgli la formazione obbligatoria.
Sulla carta non sarebbe così sbagliato. Altre categorie, come i medici, già lo fanno, sia pure con discutibili modalità. Basta una generosa casa farmaceutica disponibile ad organizzare un seminario tutto pagato in qualche ridente e costosa località turistica e il medico di turno si ritrova formato e abbronzato il giusto.
Abbronzature a parte, studiare fa bene a tutti, a qualunque età. Ma un giornalista lavora con le notizie. Prima di scrivere, parlare o riprendere con la telecamera deve essere in grado di distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è. Deve sapere andare oltre le apparenze e per farlo deve conoscere la realtà e anticipare le tendenze in atto nella società. In altre parole, non si può essere giornalisti se non si capisce l’importanza dello studio, di un processo di formazione continua che non può essere imposto per legge, ma fa parte integrante del modo di lavorare di ogni professionista degno di questo nome. Che cosa altro era il rito della lettura dei giornali la mattina appena entrati in redazione? Che cosa altro è oggi l’uso della rete, che presuppone se non altro una buona conoscenza dell’inglese? Un giornalista ignorante, per come la vedo io, non è un giornalista, ma un truffatore. E non sarà la formazione obbligatoria pensata dai nostri burocrati a migliorarlo.
Anche sui corsi, poi, ci sarebbe molto da discutere. Alcuni ordini regionali li hanno organizzati gratuitamente, in altre regioni si pagano. Variegati i temi, dalla deontologia al corretto uso di internet passando per la più bieca convegnistica. Complesso il meccanismo di calcolo dei crediti che ogni iscritto dovrebbe accumulare nel corso di tre anni. Quasi sempre oscuri i criteri delle scelte, e questo, insieme alla presenza tra i docenti dei soliti noti, rende lecito più di un sospetto.
Consola però pensare che fino a questo momento la partecipazione dei colleghi sia quasi nulla: attorno al 10% a livello nazionale, con punte fino al 25% nelle regioni più virtuose. Verrebbe da dire: avanti così che è la volta buona. L’obiezione di coscienza è stata usata per cause ben più importanti, e con rischi molto grandi per chi la praticava. Possiamo applicarla anche in questa nostra piccola e un po’ ridicola vicenda. Fino a questo momento, per quello che ne so, non sono neppure state definite le sanzioni per gli inadempienti.
Cominciamo affossando la formazione e chi l’ha voluta. Potremmo prenderci gusto e affossare anche un ordine che non ha ragione di esistere, e infatti non esiste nella maggior parte dei paesi del mondo.
©Copyright 2021 AGM service Soc. Coop.
P.I. 11758400011
Redazione Nuova Società
Via San Quintino 1 3 - 10123 - Torino, Italia
011 2170360
redazione@nuovasocieta.it
amministrazione@agmservice.it
Registrata al Tribunale di Torino n. cronol. 5135/2017 del 15/12/2017, Rg n.15443/2017.