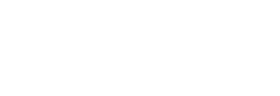Scritto da Gabriele Richetti
Il 4 marzo del 1947 – esattamente settantuno anni fa – calava il sipario sulla pena di morte in Italia. I siciliani Giovanni D’Ignoti, Francesco La Barbera e Giovanni Puleo, autori della strage di Villarbasse un anno e mezzo prima, venivano giustiziati al poligono di tiro delle Basse di Stura a Torino. Sarebbe stata l’ultima esecuzione per reati comuni irrogata da un giudice nel nostro Paese.
Quella sera in Via Cibrario davanti alla bagna cauda
Giovanni D’Ignoti, Francesco La Barbera e Giovanni Puleo, insieme al quarto complice Pietro Lala (siciliano anch’egli), arrivano a Torino durante la guerra. Nel novembre del 1945, in un’osteria di via Cibrario a Torino, mettono a punto i dettagli di una rapina: l’obiettivo è la Cascina Simonetto dell’avvocato Massimo Gianoli, stimato sessantacinquenne di Villarbasse, per il quale Lala aveva lavorato come mezzadro. Sul tavolo dell’osteria, quella sera, c’è la bagna cauda.
La sera del 20 novembre 1945, poco dopo le 20, i quattro irrompono nella cascina mascherati con dei fazzoletti e armati di pistola. Gianoli, quella sera, ha invitato a cena nove ospiti: con l’avvocato sono seduti a tavola il fattore e la moglie, il genero del fattore, tre domestiche (due con i loro mariti) e il nuovo garzone. Si festeggia la nascita del nipote del fattore. Sul tavolo, ancora una volta, c’è la bagna cauda.
Inizia il massacro
 Lala punta la cassaforte: conosce la cascina ed è convinto di trovarvi molto denaro. Ma all’improvviso il fazzoletto gli scivola dal viso e viene immediatamente riconosciuto dai commensali. Per non lasciare testimoni, i quattro banditi, dopo aver loro legato le mani con un fil di ferro, uccidono brutalmente l’avvocato Gianoli e i suoi ospiti a colpi di randello, con ferocia, uno ad uno. Dopo la strage, i quattro assassini gettano i corpi martoriati nella grande cisterna per l’acqua piovana. Le autopsie chiariranno come alcune delle vittime, in quel momento, fossero ancora vive.
Lala punta la cassaforte: conosce la cascina ed è convinto di trovarvi molto denaro. Ma all’improvviso il fazzoletto gli scivola dal viso e viene immediatamente riconosciuto dai commensali. Per non lasciare testimoni, i quattro banditi, dopo aver loro legato le mani con un fil di ferro, uccidono brutalmente l’avvocato Gianoli e i suoi ospiti a colpi di randello, con ferocia, uno ad uno. Dopo la strage, i quattro assassini gettano i corpi martoriati nella grande cisterna per l’acqua piovana. Le autopsie chiariranno come alcune delle vittime, in quel momento, fossero ancora vive.
I banditi, una volta chiusa la cisterna, salgono in casa per cercare il denaro. Lasceranno la cascina con un bottino che oggi fa amaramente sorridere (circa 200mila lire, qualche salame, dieci fazzoletti e tre paia di calze. I salami saranno consumati subito, sulla strada verso Torino).
Come se nulla fosse successo…
La mattina successiva, 21 novembre 1945, un lattaio passa dalla cascina, come è solito fare, per ritirare il latte da vendere nel suo negozio. Nessun rumore. Non ci sono luci nella cucina dove, a quell’ora, la domestica abitualmente prepara la colazione. Non è illuminata neppure la stanza dell’avvocato, sempre mattiniero. Dalla stalla, si sente un muggire lamentoso: le mucche non sono state munte quella mattina. Anche la casa del fattore è al buio.
Giunge sul posto un altro uomo di fiducia dell’avvocato, che ascolta le impressioni del lattaio. I due decidono di scavalcare il cancello e di entrare nella cascina. Racconteranno all’autorità giudiziaria: “In cucina c’era un bambino che piangeva, di circa tre anni, nipote del fittavolo. Dappertutto un grande disordine: piatti rotti, schizzi di bagna cauda sui muri, cassetti aperti, tutto faceva pensare che qualcosa di grave era successo. Mi precipitai in paese, presso l’unico telefono esistente a Villarbasse, per avvisare i carabinieri di Rivoli e da quel momento la nostra vita non fu più quella di prima”. Ma dei dieci abitanti nessuna traccia.
L’apertura della cisterna
Il 29 novembre la svolta: un bracciante, vedendovi spuntare dei fili d’erba e di paglia, ha l’idea di guardare dentro la grande cisterna dell’acqua. Incredibilmente, nessuno ci aveva ancora pensato. Prende un lungo bastone per ispezionare il fondo. Sente qualcosa di duro, intravvede delle sagome, con il rastrello recupera un grembiule. Dopo pochi minuti, i pompieri sono sul posto. La scena è terrificante. Dieci corpi vengono estratti dal pozzo, ai loro piedi sono stati legati blocchi di cemento. Sono l’avvocato Gianoli e tutti gli altri della cascina Simonetto. Nella cascina viene recuperata una giacca intrisa di sangue. L’etichetta è siciliana. Alle indagini partecipano polizia, Carabinieri, l’esercito Alleato ed ex partigiani. Viene offerta una ricompensa a chiunque fornirà informazioni utili.
Dopo quattro mesi, gli inquilini di una palazzina di Rivoli segnalano in quei giorni strani movimenti all’interno di un appartamento nel loro stabile. Gli inquirenti rinvengono indumenti sporchi di sangue, un paio di stivali incrostati di fango (risulterà essere quello della cascina) e una tessera annonaria a nome di Giovanni D’Ignoti, palermitano di Mezzojuso. D’Ignoti viene subito arrestato a Torino. Gli viene fatto credere che i suoi complici, ancora sconosciuti in realtà, abbiano confessato. Lui racconta tutto.
I carabinieri di Rivoli partono per Mezzojuso, dove arrestano Puleo e La Barbera, nel frattempo tornati in Sicilia. Lala ha già incontrato il suo destino, ucciso qualche mese prima in un regolamento di conti.
Inizia il processo: il 5 luglio 1946, la Corte d’Assise di Torino emette la condanna alla pena capitale. Il 29 novembre, la Cassazione la conferma. L’esecuzione è prevista per il marzo del 1947. Nonostante sulla carta si stia per abrogare la pena di morte (la neonata Costituzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1948), il Presidente della Repubblica De Nicola, vista l’efferatezza del massacro, rifiuta di concedere la grazia ai tre condannati. Sarà un caso isolato: tutte le esecuzioni previste nel 1947 verranno infatti sospese.


L’ultima esecuzione
È il 4 marzo 1947. I condannati, ebbri di cognac e sigarette, vengono accompagnati sul luogo dell’esecuzione dal cappellano Ruggero Cipolla. Sono bendati e legati a tre sedie di legno, con la schiena rivolta al plotone, composto da 36 fucili, 18 dei quali caricati a salve. A un poliziotto cade l’arma. Intanto, La Barbera bacia il crocifisso; Puleo, analfabeta, detta una lettera per i parenti; D’Ignoti appare smarrito, rannicchiato dietro la sedia.
Nessun ordine, soltanto un braccio che si alza e si abbassa fulmineo, alle 7.45 di un nebbioso mattino di marzo. È l’ultima condanna a morte eseguita in Italia.
I giornali, già andati in stampa, danno l’esecuzione per avvenuta. La Nuova Stampa apre così l’edizione quotidiana: “Tre sedie di legno, legate saldamente a paletti conficcati nel terreno, s’alzano sinistre e stecchite nello squallore dell’alba nebbiosa. Recano il segno dell’umana pietà, inciso a mezza luna nello schienale, per accogliere la gola del giustiziato agonizzante. Tutto è pronto per l’esecuzione. Dall’ombra opaca emergono nel breve cerchio della vista figure silenziose in casco nero. Le canne brunite dei fucili si riscaldano al tepore delle mani ed in ciascuna, una pallottola attende l’impulso mortale. Ai ragazzi è stato detto che metà delle armi sono caricate a salve per evitare tardivi pentimenti. Il plotone si addossa al muro grigio del poligono per nascondersi allo sguardo dei condannati e l’attesa sfiocca lenta nelle incerte trasparenze”.