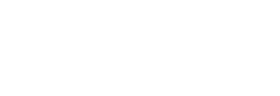Nelle boutique di libri e merchandising che concludono una mostra si comprende talvolta l’intera esposizione. Al termine di Lichtenstein. Opera prima, allestita in questi mesi a Torino, potremmo acquistare graziose lampade decorate con i seducenti motivi del pittore statunitense, per un prezzo che varia dai 130 ai 450 euro. Al fondo di Avanguardia russa. Da Malevic a Rodcenko, invece, ci viene proposto un set di “tazze da tè filosofiche” corredate di frasi del tipo “Bisogna avere del caos dentro di sé per generare una stella, ecc.”, per allietare i pomeriggi in cui (eventualmente) non avremo niente da fare. Se al tè preferissimo un caffè, tuttavia, dovremmo rifornirci direttamente all’interno, tra le “opere d’arte”: soltanto là, infatti, sono esposte delle tazzine, con relativi piattini, realizzate Vasilij Kandinskij tra il 1921 e il 1928, o analoghi oggetti disegnati da Sergei Cechonin o Nicolaj Suetin, i grafici-designer della rivoluzione d’ottobre. Design e comunismo: davvero. La tecnica del disegno applicato all’industria, che costituì sorgente sotterranea anche per la successiva, “contemporanea”, resurrezione dell’arte (dal neo-dada che esibì l’oggetto di design come objet trouvé alla pop-art, che ne offrì replica galleristica), conobbe la prima vera maturità teorica sul versante del mondo (e del pensiero politico) opposto a quello nordamericano, cui di solito è associata: l’Asia profonda scossa e divorata dall’azione dei soviet.
Prima fase di questa storia meravigliosa, a Palazzo Chiablese fino al 15 gennaio: decostruzione del canone. Lo sguardo rivolto alla Francia, i russi sperimentano sulla luce e sul colore, sul volume, sulla profondità degli oggetti; sono ispirati dagli impressionisti, da Cezanne, da Gauguin e dalla pittura Fauve. Troviamo, tra l’altro, la Casa rossa di Larionov (1900), Il lago Soloniki di Kljun (1905) o il Ritratto di Malevic (1910ca; tutti acquerelli o gouache su carta). In questo clima di messa in questione dei canoni tradizionali della rappresentazione (tipico, all’epoca, del vecchio continente) i poeti Majakovskij, Burliuk ed altri pubblicarono (1912) il manifesto Uno schiaffo al gusto del pubblico; e due anni dopo, quando la popolazione russa venne gettata nell’orrido della prima guerra mondiale, la ricerca pittorica si fece più aggressiva. Nacquero l’Unione della gioventù, o Fileia; associazioni giovanili che diedero vita al futurismo russo, detto anche “cubo-futurismo”. Ivan Kljun realizzò nel 1914 gli studi per Ozonizzatore, accanto ai quali troviamo il Ritratto cubo-futurista (R) (1915, olio su cartone) e la Donna in viaggio (stesso anno, olio su tela) di una donna appena rientrata da un viaggio in Italia e in Francia: Ljubov Popova, vera trait d’union tanto dell’esposizione torinese quanto dell’avventuroso itinerario sovversivo di quell’incredibile stagione espressiva.
Assieme a Olga Rozanova, Aleksandra Ekster, Nadezhda Udaltsova, ed altre, costituì la possente ossatura femminile del movimento artistico che avrebbe condotto, grazie all’impulso del carismatico Kazimir Malevic, al progetto suprematista. È la seconda fase: eversione non più del canone, ma del senso e dell’imperativo stesso della rappresentazione. La pittura diviene astratta, le forme angolari o gli epicentri direzionali ispirati da Boccioni, Léger o Picasso si trasformano in figure geometriche pure, incrociate o isolate sul piano, dove al bilanciamento prodotto dall’uso del colore fa da contraltare l’elemento centripeto dei diversi “campi di energia” prodotti dalla raffigurazione geometrica. “Disegnini deliziosi”, mormora qualcuno tra il pubblico. C’è di più. La forma sembra affrancarsi dal contenuto, e così l’arte della rappresentazione: senza questo vincolo, tende a rendersi pericolosamente libera da ciò che la circonda; si libra sull’ignoto, procede a una rivoluzione che si pensa già totale.
Per Malevic dipingere punti, linee e superfici è, in verità, una forma di realismo: anche il mondo geometrico è una realtà, benché impercettibile, meramente pensabile. Il suprematismo assalta il cielo di un intangibile in-esistente (esistente nella mente) diverso, ma non meno foriero di rotture con il reale percepibile, da quello che attraverserà il surrealismo. Il “realismo atipico” della pittura suprema trova espressione negli Studi sul colore e sulla forma, o nelle Composizioni senza titolo, di Ivan Kljun, realizzate nei mesi in cui la guerra si trasformava in doppia rivoluzione, repubblicana e comunista (1917). Il tangibile che circonda l’avanguardia diventa insurrezione permanente di soldati e operai, o di contadini che scannano chiunque tenti di togliere loro il grano (compresi i soldati e gli operai). L’avanguardia pittorica non reagisce rappresentando gli Orazi e i Curiazi, il Quarto Stato o una Libertà che guida il Popolo. Approfondisce il suo attacco all’arte tradizionale, entrando nella terza fase che tutto vuole sconfiggere, tutto distruggere. Dopo il canone e la rappresentazione, l’arte stessa deve morire, divenire altro.
Popova sviluppa l’idea di Architettura pittorica (olio su tela, 1916-1917): la pittura che supera sé stessa, si libera dal ghetto in cui è stata nel tempo costretta, recuperando il senso originario della nozione di artisticità. Ars, per i romani, techne (tecnica) per i greci: sistema di regole, ogni volta riformulabile, per produrre qualcosa. È arte la pittura come lo sono il cinema, il teatro, l’architettura, la rivoluzione e la guerra, la retorica e il diritto, la scienza. Il mondo è lo scenario, non la galleria; la scuola il mezzo per cambiarlo. Popova insegna allo Vchutemas, laboratorio di arti e tecniche moscovita, gomito a gomito con Kandinskij, già direttore del Dipartimento di Belle Arti presso il commissariato del popolo per l’educazione (1917), pianificatore per il governo bolscevico dei Musei della cultura pittorica e primo direttore dell’Istituto di cultura artistica (Inchuk). Mentre la rivoluzione, respinti gli attacchi neo-monarchici delle potenze europee e attraversato il comunismo di guerra, tenta la costruzione di un’economia nuova (Nep, piano aperto al mercato), l’Inchuk mette alla prova insegnanti e allievi sul tema dell’applicazione produttiva del disegno (1922). Popova, Kljun, Klucis, Stenberg, Rodcenko e molti altri si cimentano sui temi della composizione e della costruzione, immaginando un territorio poetico e tecnico dove l’astrazione già conquistata è mezzo utile a una nuova conquista: la trasformazione della realtà concreta.
Popova prova a pensare, nel disegno, l’intera città come condensato della società e dei suoi rapporti. Disegna (assieme a Vesnin) le eccezionali maquette per La fortezza capitalista e La città del futuro (1922) o, sola, quelle per il dramma teatrale La terra in subbuglio (1923). È ora – quando si scatena l’amore suo e di questi avventurieri della forma per tutto ciò che c’è da costruire, per l’oggi e il domani – che il costruttivismo trapassa in produttivismo. L’arte si trasforma in design, il mondo antico in nuovo, le arti in industria dispiegata. Popova ci delizia con i suoi Motivi per tessuto del 1923-24 (giacché il design è anche abbigliamento, tanto per il teatro quanto per la vita); con la Copertina di libro ricamata degli stessi anni; con gli allestimenti teatrali realizzati insieme a Vyalov, Ekster o Kudashev. Tra questi, i collage carta su carta Musica e rivoluzione e Avanti verso il comunismo che, a Palazzo Chiablese, si trovano accanto alle tazzine e ai piattini disegnati da Kandinskij. Tazzine e comunismo: chi tiene in mano lo stilus, l’oggetto appuntito che lascia una traccia, non si rinchiude più nel buffo mondo del “genio”, ma collabora con la gente per migliorare la vita sua e degli altri, anche durante un caffé.
Allora fermiamoci: chiudiamo gli occhi e immaginiamo di sorseggiarlo con Popova, Kandinskij e Rodcenko; di non essere in questa ennesima mostra, ma di usare quelle tazzine. Il potere del capitale sulla storia, o quello dell’ideologia sulla creazione, sono morenti, sotto il tacco del nostro stivale. L’arte si avvia ad essere altro. No: apriamo gli occhi, di fronte a noi c’è Ritmo espressivo di Malevic, opera tarda, realizzata quando tutto era già finito (1943-44). Le pennellate si disperdono istintivamente, e si ritrovano, lungo lo spazio di una grande tela. L’esposizione suggerisce un “confronto provocatorio” con Jackson Pollock, “nell’ambito delle affinità elettive”. Questo rimane, di tutto quel fuoco: una concezione addizionale della storia (e dell’arte) incapace di vedere i salti e i traumi, i passi avanti e quelli indietro, perché anziché interrogarsi, memorizza. Questo resta: corrispondenze cronologiche o di scuola; “affinità elettive”.
È difficile vedere la novità travolgente di ciò cui siamo abituati. Difficile è afferrare la potenza eversiva del mondo odierno, tutto così disegnato; e dell’idea, catturata e valorizzata dalla produzione capitalistica, di mettere in comune le capacità e offrire il risultato a tutti (ridotti però a “consumatori”, e i designer a “capitale umano”). Difficile astrarre da tutto questo e pensare il disegno produttivo nella sua opera di decostruzione costante della costellazione culturale che ancora ci avvolge, dove l’immaginazione e la critica sono neutralizzate in un redivivo “mondo dell’arte”, e il disegnatore industriale si limita a eseguire ordini. Difficile dispiegare l’intuizione feconda della produzione di cose, di ricchezza, come elemento immediatamente orientato alla messa in comune dello sforzo produttivo, alla liberazione dell’accesso consumo, o sorprendere la spettra di Ljubov Popova inquietare i sonni dei parrucconi/artisti, anche giovani e belli, con il suo lascito complesso di opera multiforme, appassionata – vissuta come una guerra, non come una posa. Più facile scrivere, sui pannelli (con un lessico così povero da apparire autoironico) che il produttivismo “fu un’arte politicizzata”. Chissà che vuol dire; ma è giusto, il difficile non si mette mai come tale in mostra, ha un residuo in-mostrabile. È come il design: non si dice ma si fa; e anche quando il risultato è disseminato ovunque, appare sempre altrove.
©Copyright 2021 AGM service Soc. Coop.
P.I. 11758400011
Redazione Nuova Società
Via San Quintino 1 3 - 10123 - Torino, Italia
011 2170360
redazione@nuovasocieta.it
amministrazione@agmservice.it
Registrata al Tribunale di Torino n. cronol. 5135/2017 del 15/12/2017, Rg n.15443/2017.