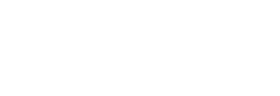Cinque titoli del Torino Film Festival hanno affrontato, in questa edizione (tra altri) il rapporto tra la società in trasformazione e il potere. Con diversa profondità e finalità espressive differenti, hanno toccato questo soggetto collocandolo in occidente o in oriente, in Italia o all’estero, nel passato o nel presente.
Si è iniziato con Diplomatie, opera del 2014 di Volker Schlöndorff, vero momento di inaugurazione del Festival. Il governatore militare della città di Parigi, occupata dalle truppe naziste nel 1944 – generale Dietrich von Choltitz – deve eseguire un ordine di Hitler: distruggere Parigi prima di abbandonarla all’arrivo delle truppe alleate, che stanno procedendo a pieno ritmo verso sud-est. Utilizzando un passaggio segreto costruito da Napoleone III nel palazzo che ospita il governatore (l’Imperatore l’aveva costruito all’epoca per incontrarvi una sua amante) il console svedese Raoul Nordling si introduce nottetempo nelle stanze di Choltitz con l’intento di convincerlo a desistere da questo assurdo proposito.
Ne segue un dialogo, che dura quasi ininterrotto tutta la notte. Tutti i ponti della città (con l’eccezione del Pont Neuf) e i principali monumenti storici (Palais du Louvre e Tour Eiffel compresi) sono già minati dagli uomini di Choltitz, in attesa del suo ordine per cancellare la Ville Lumiere. Choltitz spiega a Nordling che un militare non può, dopo aver giurato, rifiutarsi di obbedire a un comando gerarchico, quand’anche non lo condividesse. Il console si avventura a indagare, allora, quali siano i limiti possibili di questa professione di fedeltà: non si tratta infatti di una fede in senso religioso, simile a quella che condusse Abramo ad accettare di assassinare il figlio Isacco per ordine di Dio, giacché la radice del giuramento militare è terrena e civile, piano su cui non può entrare in contraddizione con i principi fondamentali della rispettabilità e dell’onore.
Quali sono, dunque, questi principi? Qualsiasi violenza un esercito sia portato a commettere durante una guerra, deve essere commisurata alle necessità militari: il sentimento privato non può essere un criterio, pena l’evidenza della mancanza di autocontrollo e disciplina, quindi il disonore rappresentato da una disordinata irrazionalità. Ora, evidenzia Nordling, non c’è alcuna ragione razionale concreta, sul piano bellico, per la distruzione di Parigi: un tale atto non varrebbe in alcun modo a rallentare l’avanzata angloamericana, ma si situerebbe esclusivamente sul piano della frustrazione interiore e sul profondo risentimento di chi rappresenta l’origine giuridica e gerarchica di quel comando, Adolf Hitler. L’argomentazione – perspicua al soldato Choltitz – con il passare delle ore, scava lentamente una breccia nella sua coscienza di uomo d’armi, che pure si è macchiato di crimini orrendi (in verità anche più spropositati: si pensi al massacro degli ebrei in altre regioni europee, di cui era stato effettivamente protagonista). (Si noti di passaggio che l’abbattimento dei ponti e la conseguente esondazione della Senna avrebbe allagato il sud-est della città aggiungendo alla catastrofe storico-artistica anche quella umanitaria).
Se la discussione sul tema dell’autorità è l’elemento più riuscito dell’opera, degni di nota sono anche alcuni altri temi, come i riferimenti del nazista alla ferocia dei bombardamenti alleati (anche sui civili) da parte inglese e il suo disprezzo per la popolazione di Parigi, sempre sul piano della rispettabilità militare, per non aver opposto resistenza nei giorni in cui la città fu occupata dal Reich. Questioni disturbanti, naturalmente, e politicamente scorrette, che fanno rimpiangere l’assenza di una maggiore divagazione critica anche sul tema della conservazione della città, la cui necessità “culturale” o “storica” – per molti versi intuitiva, eppure non scontata allo sguardo asciutto sui cambiamenti e le mutilazioni di cui essa era già, comunque, risultato – è presupposta come ovvia nell’impianto narrativo.
Non tutti i tentativi di approcciare il tema del politico sono stati così riusciti al Tff. Oscura appare la ragione della selezione del documentario Attacco alla democrazia – inserito in un’apposita serie che proprio all’omonimo tema è stata dedicata – che ci propone una decina di verbosi interventi di accademici tedeschi sul tema della crisi economico-politica apertasi nel 2008 e sulle sue conseguenze sui meccanismi decisionali e sul tema del rispetto della volontà popolare. Anche prescindendo dallo humor a dir poco patetico di cui molti dei protagonisti sono dispensatori, ciò che colpisce è la banalità degli interventi, dalla profondità analitica sostanzialmente nulla, ma grondanti indignazione piccolo-borghese per fenomeni che, se tanto ci da tanto, proprio con la democrazia come assetto istituzionale storico hanno sempre avuto a che fare (soggezione al potere economico, carattere fittizio della sovranità popolare).
In ultima analisi, tutti gli interventi alludono a una democrazia compiuta che è entrata in crisi negli ultimi anni, senza fornire evidenze di una sua esistenza reale precedente. La stessa contrapposizione ricorrente, durante il convegno (tenutosi a Berlino nel 2011, filmato da alcuni operatori e montato da Romuald Karmakar), tra “politica” ed “economia”, “finanza” e “cultura”, “politici” e “intellettuali”, esprime in modo plastico il semplicismo astratto con cui viene trattato il rapporto tra società, bisogni, tecnica economica, controllo socio-culturale e potere, evidenziando in ultima analisi quanto proprio l’intellighentia accademica sia stata in questi anni uno dei maggiori problemi più che un potenziale soggetto alla ricerca di soluzioni: ambito separato, convinto di poter esercitare una malintesa egemonia morale su un pubblico comunque considerato in modo paternalistico, sbandiera in modo affettato un’indignazione imbelle e non supportata da adeguate capacità analitiche.
Il problema, ovviamente, non riguarda soltanto le Università: lo dimostra il film Iranien, del regista natio delle terre persiane (ma residente a Parigi) Meheran Tamadon, che riesce nell’impresa di invitare per due giorni, nella sua lussuosa abitazione di Teheran, quattro Mullah per affrontare il tema della democrazia e trovarsi in estrema difficoltà dialettica. Esibisce involontariamente, ma in modo comunque imbarazzante, tutta la debolezza degli argomenti liberali di fronte ai pur disgustosi principi su cui si regge la repubblica islamica.
Come? Gran parte della discussione ruota, in modo diretto o indiretto, attorno alla questione dell’autodeterminazione femminile (che ovviamente non viene mai nominata in questi termini, troppo crudi anche per il pensiero “occidentale”) e il povero Tamadon è convinto a torto di poter padroneggiare l’argomento. (Non senza imporci l’ostico fardello di sopportare novanta minuti di tenzone filosofica sulla donna senza la presenza di una singola donna quale interlocutrice: sono presenti, come mere ombre, le mogli di due Mullah, ma il regista – probabilmente su richiesta dei mariti – si guarda bene dall’inquadrarle).
Gli antagonisti di Tamadon imboccano subito la via del successo argomentativo. Il più carismatico e intelligente tra i quattro propone immediatamente quale base(a ben vedere corretta) della discussione l’assunto liberale secondo cui il limite della libertà di ciascuno risiede nell’offesa alla libertà altrui. Operando un arguto spostamento retorico il Mullah sostituisce (senza che Tamadon sia in grado di accorgersene) “libertà” con “sensibilità” e sostiene che le donne devono avere rispetto per tale “sensibilità” degli uomini, che possono restare turbati (l’uomo dice, in verità, “eccitati”) dalla vista delle loro spalle o dei loro capelli.
Il regista obietta allora che questa esigenza maschile deve temperarsi in quella femminile a poter scegliere come uscire per strada, ed ottiene in risposta una domanda arguta: “Lei ammetterebbe, a Parigi, che le donne uscissero per strada completamente nude?”. Alla prevedibile risposta negativa del malcapitato (prevedibile perché si capisce da subito che è a sua volta un baciapile) il Mullah opera spietatamente lo scontato affondo: tanto Teheran quanto Parigi limitano le libertà della donna, sia pur in modo diverso e in diverso grado; ma Parigi pretende di imporre il suo metro come quello universale, contrariamente a Teheran, che si limita a difendere strenuamente il suo. “Siamo dittatori e diciamo di esserlo, voi vi dite liberali ma siete dittatori e fascisti almeno quanto noi” sono, più o meno, le sue parole.
I quattro Mullah muovono quindi, in modo coordinato, l’assedio al povero Tamadon su un tema che egli non è, ahilui, in grado di controllare: quello dell’universalità dei precetti e dei limiti morali, anche quando tradotti in legge. Il regista tenta di obiettare che, se alcuni uomini non sono in grado di controllarsi di fronte alla corporeità dell’altro sesso, devono affrontare i loro problemi interiori in privata sede, senza nuocere agli altri. Buona l’intenzione, ma non c’è cornice argomentativa adeguata, e i famigerati quattro negano recisamente (con ragioni evidenti,e persino piuttosto moderne sul piano filosofico) che esista un criterio “scientifico” (anche psicoanalitico) che possa dirsi universale per diagnosticare ciò che, sul piano interiore, può esser detto in assoluto “un problema”.
Ecco il regista di nuovo in crisi, ride senza saper cosa rispondere, si lascia convincere persino, in un momento di confusione, a raccogliersi in preghiera (lui, che si definisce ateo) e stenta a controbattere pure alle incredibili argomentazioni dei religiosi sulla musica (se troppo ritmata, provoca scompensi ormonali; se la voce è femminile, provoca insopportabile eccitazione sessuale; e via di questo passo).
Cosa ne deduciamo? Che Tamadon è ben rappresentativo di un tipo umano, non dissimile da quello dei prof tedeschi impegnati a spiegarci la democrazia sotto l’attacco della finanza. Questo tipo umano è quello di colui che crede che il mondo sia una cosa semplice. La ragione di questa assurda credenza è radicata nel bombardamento propagandistico che, presentandoci quelle tre o quattro convinzioni fondamentali come autoevidenti (vuoi attraverso le istituzioni formative, vuoi attraverso i telegiornali o il cinema), ci disabituano a indagarne i reali fondamenti logici. Conseguenza? Gran parte dei presunti “intellettuali” europei si troverebbero in difficoltà in una tenzone filosofica persino contro le folli argomentazioni di quattro perditempo ossessionati dalla musica e dalle forme femminili.
Non è che l’oppressione capitalistico-finanziaria odierna, o l’oscurantismo religioso, non siano un problema che è possibile affrontare sul piano concettuale; è che né la “democrazia” (concetto agitato se va bene in modo contraddittorio, se va male in modo del tutto vuoto) né il liberalismo (che Tamadon chiama in modo del tutto improprio “secolarismo”) possono essere, tanto a livello pratico quanto a livello teorico, la soluzione pratica o teorica. Questa soluzione, allora, qual è? Forse, proponiamo, iniziare a fidarsi meno delle risposte pronte o delle argomentazioni ovvie, magari ricalcate su quelle dei talk-show, e concepire il cinema più umilmente come apertura e ricerca – con possibili ricadute positive anche sul piano estetico. Ne sono dimostrazione gli altri due film su cui vogliamo spendere alcune righe: The Iron Ministry di J.P. Sniadecki e Qui di Daniele Gaglianone.
Nel primo caso, non è al parlato che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. I dialoghi (si tratta di un documentario) appaiono talvolta sapientemente selezionati, filtrati per proporre ancora una rappresentazione ideologica e modernamente (estremo)orientalistica della realtà. Il filmato, più interessante, ci restituisce un viaggio in treno lungo l’intera repubblica cinese, lungo gli ultimi tre anni. Scorci urbani, infrastrutture, piani naturali; ma soprattutto: fessure, tubature, rubinetti, arnesi meccanici inquadrati a camera fissa a decine di riprese, nei luoghi più improbabili di questa vecchia-nuova macchina dell’orrore e della speranza che è il tanto familiare, eppure a tutt’oggi in gran parte inesplorato, treno.
Ciò che è apprezzabile in The Iron Ministry è il fatto che Sniadecki abbia voluto prendersi il tempo per lasciar essere qualcosa (non c’è alcuna suggestione heideggeriana in questa mia espressione), sapendo dare un ritmo ai rumori e ai suoni della macchina in moto là dove noi solitamente udiamo, distratti da altre occupazioni della vita, soltanto una collazione disordinata di percezioni sensibili – qualcosa che ci appare privo di senso. Così ci appare perché, a ben vedere, così è; eppure a questo può rivolgersi la macchina da presa: alla costruzione di una direzione al tempo stesso immaginifica e sensoriale, che ci conduca là dove l’esperienza extra-cinematografica, sovente, non ci conduce. Un luogo squisitamente estetico, non per questo irrelato al pensiero, che può suggerire innumerevoli percorsi ideali all’osservatore, offrendo uno sguardo dischiuso su uno dei temi più militarizzati (l’Oriente, la Cina).
Da un’apertura all’altra, da un treno all’altro: Qui, ultima (e, secondo molti, fino ad oggi suprema) fatica di Gaglianone, si contrappone specularmente al distante “altrove” di Sniadecki; in Val di Susa, a trenta chilometri da Torino, un’intera popolazione si oppone alla costruzione di una nuova linea ferroviaria, l’alta velocità Torino-Lione. Una sfilza di personaggi, reali e surreali a un tempo, ma tutti veri, narrano episodi di lotta, passaggi dal carcere, preghiere, scontri con la polizia, dialoghi in prefettura, tentativi di comprendere il ruolo che nella società occupano le istituzioni, la lotta, l’autogestione, l’informazione, la polizia. Il regista è assente sul piano retorico o propagandistico: riesce a realizzare un film partigiano senza far sentire la propria voce o lasciar intervenire il sottofondo pur invisibile o sottointeso di una didascalia scontata (“non è un volantino” dice, giustamente, presentandolo).
Il film, però, è “schierato”, si chiede in modo stucchevole la stampa in sala? Certo: di Gaglianone si respira la passione ad ogni istante, la si odora nelle inquadrature sapientemente affaticate, nella regia sofisticata che penetra il cuore dell’osservatore senza rivelarsi, le debolezze come la forza delle persone intervistate. Certo, c’è anche della finzione: quella pertinente a qualsiasi selezione dell’inquadrabile e del catturabile sul piano fotografico o sonoro, quella che si annida nell’inquadratura come elemento ineliminabile del cinema. Certo c’è anche la forzatura, certo c’è la direzione e l’impronta politica data non dalle parole, ma lasciata al vedere e al sapere delle immagini, rendendo giustizia, cosa rara, all’autonomia della macchina da presa dalla scrittura intesa in senso linguistico.
Che cosa, però, non c’è? Non c’è la morale stantia e pedissequa di chi non nutre alcuna fiducia nella capacità del pubblico di formarsi autonomamente un’idea, non c’è il canovaccio qua o là prevedibile di chi vive il cinema come elemento alienato, professione, compito di una qualche responsabilità sociale che poi vuol sempre dire rispettoso dei cardini logici ed estetici del potere di turno: “Io ho parlato sempre di me stesso nei miei film, ed io sono anche questo”, afferma il regista, commuovendosi, alla prima.
Qui è un’opera che ci è apparsa libera, spensierata anche se profondamente pensante, entusiasta anche se registrata sul respiro rotto e drammatico di una valle occupata, assediata, rimossa, violentata. Una valle che non abbiamo realmente conosciuto, in questi anni, se non da resoconti indipendenti dal punto di vista governativo, giudiziario, poliziesco, ufficiale; e il film di Gaglianone (bisogna dargliene atto) è stato finora uno dei tentativi più belli, sinceri e penetranti di contrapporsi a tutto questo sapendo arrivare ai nervi, alle rappresentazioni più o meno consolidate, alla dimensione emotiva per definizione oscillante delle persone; un film che ha saputo avere rispetto della valle, dei suoi abitanti e protagonisti e del più grande fenomeno del pubblico cinematografico al tempo stesso.