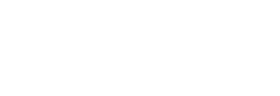Cosa induce un’elegante signora in nero, avvenente anche senza il fiore degli anni, con negli occhi una strana, intrigante eccentricità, a condividere il suo tempo con un ragazzino di Mirafiori in sfavillante mise colorata (convinto – sue testuali parole – che quanto più veste “tamarro”, tanto più l’universo femminile sarà caritatevole col suo destino)? È sabato sera, e nelle celebri maniche progettate da Amedeo di Castellamonte e Filippo Juvarra si serve vino in discreta quantità, in onore della notte e di ben due compleanni, con tanto di torta, spumante e canzoncine di auguri. Il “bene culturale” protetto dall’UNESCO, cartolarizzato dal comune, controllato dalla Compagnia di San Paolo, occupato da mesi da un’ampia assemblea che si oppone alla vendita – e infine, pochi giorni fa, in parte incendiato da ignoti – offre come biglietto da visita uno strano mix di portamenti, accostamenti e, naturalmente, intrattenimenti.
In una delle sale, tra luci soffuse, un centinaio di persone applaude le prodezze di un giocoliere; sotto il portico, nella manica lunga, c’è un’improvvisazione Jazz. Non siete obbligati a guardare o ascoltare; più probabilmente vagherete, come qui fan tutti, da un luogo all’altro, da un ambiente all’altro, e a furia di girovagare nel portico alla fine vi siederete a un tavolo pure voi, protagonisti involontari di questo piccolo festival (ora affettato, ora involontario) di uno spicchio puntuale dell’unica Maestà che qui sembra essere riconosciuta: la varietà urbana. Certo, c’è anche chi ti aspetteresti di incontrare: un tizio col cilindro di nome Brice mi viene presentato come artista con tutti i crismi e, dopo qualche minuto di immancabile sarcasmo, sostiene che la vendita di questo luogo non è accettabile, poiché ne stravolgerebbe i caratteri e l’identità. Quale pezzo di mondo, gli chiedo tuttavia, non muta identità e caratteri con il passare del tempo? Questo luogo ha una storia – risponde – e questa storia va rispettata, accudita, valorizzata.
Tutto ha una storia, penso tra me e me; se ce l’ha è perché si trasforma, non necessariamente in continuità o sintonia con ciò che era prima. Lo mostra questa occupazione, che ha a dir poco stravolto (se non fisicamente, socialmente) la storia della Cavallerizza. Marco spiega il suo punto di vista sulla questione. Fa parte di un gruppo di operatori dello spettacolo e intende affrontare il mercato tentando di mettere a valore anche le capacità maturate attraverso l’esperienza dell’occupazione. Il valore del luogo, per lui, è più legato alla relazione con ciò che c’è fuori che a quella con ciò che era prima, più allo spazio che al tempo. In pieno centro urbano e storico, la nuova Cavallerizza gli sembra irradiare la sua presenza vivente verso ogni angolo della città, grazie alle cento nuove attività teatrali, musicali, politiche che in questi mesi l’hanno travolta; e da ogni angolo della città gli sembrano provenire, di rimando, le mille personalità metropolitane, di generazioni diversissime, che vagano per queste maniche e per queste stanze, giorno dopo giorno, sera dopo sera.
Potremmo lisciare, a queste personalità, ambiguamente il pelo. Potremmo indugiare sulla descrizione dello zoo, affinando il bestiario che offrono, un tanto l’etto, le testate importanti. “Abiti modestamente eleganti o colmi di allusioni orientali accanto a camice di acrilico e ironiche cravatte; tatuaggi, tagli coraggiosi o pettinature dimesse; patetiche pose da bohèmien e malcelate attitudini erudite, nostalgiche o militanti”; o addirittura “piercing e scarpe col tacco accanto a cattedratici che vivono una seconda gioventù”. Sarebbe un errore: ridurre simili esperienze a folklore è funzionale alla liquidazione buonista, democratica in senso repressivo, delle sfaccettature sociali che compongono questo luogo e la sua città.
La Cavallerizza di questi mesi può essere divertente, allegra o noiosa, ora gradevole ora respingente, ma non è riducibile a un fenomeno da baraccone. L’umanità che la bazzica è sì, talvolta, compiaciuta – lo spiega Rubina, che si dedica a questa esperienza, anima e corpo, fin dall’inizio – perché passare una serata qui è in questo momento anche trendy; ma lo zoccolo duro che è nato e cresce attorno all’occupazione, tiene a sottolineare, non viaggia su queste frequenze. Intorno ad esso si solidificano bisogni materiali e possibili rivendicazioni sociali, per un terreno del contendere che va ben oltre, e in potenza sembra lasciarsi alle spalle, il malinteso “istinto di conservazione” proprio della cultura occidentale moderna, con la sua museificazione astratta dei mondi, la mummificazione selettiva del passato e del presente, la caricaturale valorizzazione della differenza (fino a quando è politicamente innocua) pronta per il primo scaffale concepito dall’UNESCO per il nuovo millennio (le “eredità intangibili” della Convenzione del 2003).
“Ciò che m’importa non è preservare questo muro” dichiara francamente, non a caso, Roberta. Danzatrice, occupante in prima fila e dalla prima ora, indica la parete barocca della struttura. “Questo luogo e il suo uso attuale – spiega – pongono un problema che trascende il destino dell’oggetto architettonico e persino il suo valore immanente, comunque inteso”. Muro, oggetto fisico: al centro delle convenzioni internazionali e dei parametri per la tutela del “bene” culturale, appare più un terreno di contesa interna allo spazio definito dal diritto che il campo di manovra su cui intendono operare coloro che si pongono di fatto, occupando questo spazio, in una promettente illegalità. È uno spostamento interno al senso stesso di “bene” che l’occupazione sembra produrre; uno smottamento che arriva a incidere persino sui criteri della valutazione estetica. “È bella per me, perché l’ho imbevuta della mia esperienza in tutti questi mesi” esclama Giulia; Carla, che ha appena messo qui in scena uno spettacolo di cui è autrice e attrice, afferma invece che, se la Cavallerizza è bella, è perché “trae bellezza dall’apertura dei suoi spazi”. Osservazione raffinata, perché inquadra l’impianto architettonico, come pensiero o suggestione, nel rapporto con il movimento possibile dell’ingresso e dell’uscita (di corpi come di sguardi) – con l’attraversamento. Ciò che qualifica l’architettura come sedimentazione concreta del vissuto storico e sociale. Ciò che la riporta sul piano di realtà che ha prodotto i più grandi exploit della sua storia.
L’uscita dalla mera virtualità di tali implicazioni è forse anche in ciò che Carla descrive come il lascito recente che qui è senza indugi da preservare: l’uso di massa del luogo. Un luogo che, più che passato è, adesso, “trapassato”. Allude a questo anche Elena, seduta di fronte a lei (sebbene non si conoscano) e arrivata da Chieri con un’amica. Studia Ingegneria e non fa parte dell’assemblea, né vive quotidianamente lo spazio; eppure è proprio l’elemento direttamente politico, assembleare e di incontro, che per lei tutti dovremmo difendere dai privati, dal comune, dalla polizia. Scavando e domandando ci si accorge che tutte le osservazioni dei presenti si concentrano su questo orizzonte presente: la progettazione comune, allargata alla città, intesa come folto popolo e imprevedibile massa umana, è la riappropriazione di spazi dove produrre piacere ma anche organizzazione politica, forse possibilità dal basso di lavoro o reddito. Chi si esibisce qui lo fa gratis, ma Roberta racconta che, da quando l’occupazione ha avuto luogo, lei e le sue compagne di danza hanno avuto la possibilità di produrre con una continuità e un impegno che prima sarebbero stati impensabili: con quali soldi avrebbero affittato uno spazio per le prove, per tutte queste ore del giorno e della notte?
Spazio libero per l’attraversamento di simili e altri bisogni, occupato anche per chi deve coltivare tutto ciò che ha per vivere: la propria forza lavoro fisica, emotiva, intellettuale, tanto più nel mondo brutale, da sempre votato all’iper-sfruttamento, dell’industria spettacolare e dell’arte. Tanti pezzi metropolitani di quella che potremmo vedere come una sorta di “classe operaia dell’intangibile” stanno sciamando alla spicciolata verso questa “nuova”, strana Cavallerizza, con un’accelerazione proprio in queste settimane, dopo la pausa estiva. Le occasioni per esibirsi o produrre spettacoli fuori dai circuiti ufficiali del teatro, ricorda d’altronde Carla, sono sempre più rare; senza contare che questo piccolo esercito di attori, tecnici, musicisti ha un rapporto ambivalente con quei circuiti, descritti non di rado come votati alla mediocrità o piagati dalla corruzione clientelare, nonostante siano per molti l’unica meta possibile – benché non desiderabile – per guadagnarsi il pane. Se l’occupazione ha spalancato una possibilità di mettersi all’opera e alla prova, allora, gli “operai della cultura” presenti in assemblea radicano esplicitamente l’importanza di questo progetto nelle proprie condizioni materiali, in prospettive di riscatto che tentano di comporre l’esperienza e le esigenze del singolo con quelle del gruppo di lavoro, e queste ultime con quelle del collettivo assembleare e della città. Questa sconosciuta. Questa entità palpabile soltanto a tratti, dagli occupanti sempre invocata con un vago senso di attesa, quasi avesse stipulato con loro un antico, segreto, silenzioso patto di fratellanza.
Per un paradosso apparente, ciò che gli occupanti cercano in questa avventura sembra essere proprio la mutazione radicale dell’uso di questo spazio; l’occupazione ha condotto alla sostituzione del non-uso o quasi-uso precedenti con un uso nuovo, che non avvantaggia i potentati finanziari della metropoli, ma tutti; chi cerca una città diversa da quella che c’è, chi lavora in quel ramo dell’industria che le scienze umane chiamano cultura. Forse è questo che permette quella sorprendente, quanto fragile, ricomposizione sociale che – come spiegano Roberta e Carla – l’occupazione della Cavallerizza sta rendendo possibile. Tante Torino vi si incontrano: giovani precari dalle idee politiche molto definite, settori del personale universitario più o meno traballante, chi si inventa produttore autonomo nel mercato spettacolare e chi (e sono molti) vede nei luoghi storici della città il residuo remoto dell’austera Torino che ha amato per tutta la vita e, dopo la scomparsa dell’altra immaginaria cattedrale urbana (la “città-fabbrica”) vorrebbe salvarne un pezzo. “La cavallerizza è reale”, scrivono sul blog gli occupanti; non è forse una novità assoluta? L’eredità posta sotto tutela dall’assemblea è quella di una “storia” che si scrive adesso. Nulla da difendere, apparentemente, se non ciò che si è appena iniziato a costruire.
©Copyright 2021 AGM service Soc. Coop.
P.I. 11758400011
Redazione Nuova Società
Via San Quintino 1 3 - 10123 - Torino, Italia
011 2170360
redazione@nuovasocieta.it
amministrazione@agmservice.it
Registrata al Tribunale di Torino n. cronol. 5135/2017 del 15/12/2017, Rg n.15443/2017.