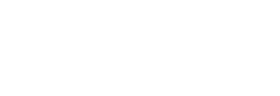La discussione sulle 35 ore, sulla riduzione dell’orario di lavoro, aperta dalla proposta di Marco Grimaldi, consigliere comunale di Leu, Liberi e Uguali, ha precedenti illustri. Risale addirittura alla metà degli anni Cinquanta ed ebbe, ieri come oggi, il suo epicentro (e primato intellettuale) nella sinistra torinese e, in particolare, tra i militanti e dirigenti della Fiom-Cgil. Nello specifico il confronto mosse i suoi primi passi dalle proposte formulate dalla commissione interna della Lancia di Borgo San Paolo, che aveva il suo leader in Piero Mollo, un operaio non ancora trentenne, anima de La Scintilla, il giornale di fabbrica, che qualche anno dopo sarebbe diventato consigliere comunale in Sala Rossa e giornalista della redazione torinese de l’Unità.
In quel decennio la prua dell’intellighenzia operaia comunista puntava decisamente per l’allargamento della base occupazionale in una fase di profonda crisi economica, in cui la stessa Fiat era stata costretta a ridurre i suoi occupati, seguita a ruota da numerose piccole e medie imprese torinesi, solo una parte orbitante nel sistema automobilistico. E l’utopia – lo era sicuramente all’epoca – delle 35 ore camminava a fianco della parola d’ordine che il capo della Cgil, Giuseppe Vittorio, aveva lanciato nel Paese: «ritornare alla fabbrica». Una necessità, prima che una scelta, dopo l’arretramento della Fiom nelle elezioni di commissione interna del 1955, che oggi curiosamente si ripresenta con la variante «riprendiamoci le fabbriche» per reagire alla pesante deindustrializzazione cui è stata sottoposta Torino, orfana della Fiat.
Negli anni Cinquanta il proposito delle 35 ore non superò la soglia della discussione, arenandosi sulle conclusioni di un effervescente convegno. Non lo superò anche per essere stato a sua volta superato dal boom economico, dalla potente marea della motorizzazione di massa che fece lievitare gli indici dell’occupazione. Ma, non fu questo il motivo iniziale del mancato consenso tra gli operai. Ieri come oggi, la ragione primaria fu determinata dal modesto appeal per la questione retributiva. Ieri come oggi, i salari – fatte le debite proporzioni rispetto al costo della vita e al contesto sociale – erano modesti, se non bassi, e minimo era il potere contrattuale per ipotizzare una redistribuzione della ricchezza con il concorso del padronato, e l’intervento regolatore dello Stato non rientrava tra i compiti dello Stato… (le Regioni erano rimaste ancora appese alla Carta costituzionale).
Questo spiega perché i tentativi di sindacati e delegati di fabbrica a cercare sponde ai contratti di solidarietà ricevano anche oggi uno scarso indice di gradimento tra i lavoratori, più inclini a subire la cassa integrazione, che a modificare comportamenti o a vedersi limitare l’orizzonte di altre opportunità di integrazione salariale. Ma il potere d’acquisto dei salari non è soltanto uno dei problemi, se non il problema del Paese, quanto del mondo intero, se è vero che la forbice tra incremento della produttività e aumento della busta paga si è dilatata in una forma che ha determinato e continua a determinare un generale impoverimento delle popolazioni, che ha avuto come prima ricaduta un allarmante abbassamento culturale e comportamentale.
Sic stantibus rebus, la riduzione dell’orario di lavoro anche a parità di salario può diventare pervasiva solo a patto di una politica di robusti investimenti e di innovazione tecnologica accompagnata da un’autentica rivoluzione culturale che premi la riflessione sui bisogni del Paese e delle comunità, su che cosa produrre, come e dove produrre, in cui lo sviluppo proceda insieme al rispetto per il lavoro e la sua sicurezza.
Lavoro come baricentro ideale della società che non si può, né si deve reggere su facile accomodamenti, come rischia invece di essere interiorizzato il salario garantito.
Le 35 ore? Riprendiamoci le fabbriche