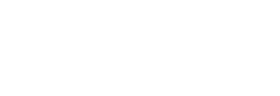Il pregio de “L’importanza di essere Ernesto”, di Oscar Wilde, è tale che persino il talento di chi mette in scena l’opera può apparire, a tratti, secondario. Rappresentata per la prima volta a Londra nel 1895, e strutturata in due parti (un primo atto dove gli eventi si preparano, un secondo in cui una serie di coincidenze e paradossi attuano con ostentata spensieratezza l’impianto delle pennellate tardo-vittoriane), ci offre un mix sagace di comicità e, come sempre in Wilde, raffinato cinismo. Le luci curate da Luigi Ascione seguono per semplicità l’impostazione minimale, ma elegante, della scenografia ideata da Teresa Emanuele e Geppy Gleijeses. Gleijeses firma anche la regia e impersona il protagonista, Jack (il cui alter ego, durante gli svaghi dalla campagna, ottenuti compiendo prodezze a Londra, ha appunto il nome di Ernest). Graziosi i costumi disegnati da Adele Bargilli.
Questa soluzione teatrale, calibrata sulla traduzione di Masolino d’Amico e interpretata da attori non sempre sfavillanti (proprio a partire da Gleijeses, piuttosto scolastico), vede il personaggio più riuscito nell’impagabile scapestrato Algernon, giovane dandy metropolitano la precisazione delle cui malefatte, cui si fa continuamente riferimento ammiccante nella commedia, sono affidate dall’inizio alla fine all’immaginazione dello spettatore. Il compito d’impersonare questo personaggio ozioso, indolente, estremamente godibile, cui l’autore affida un buon 70% della sua frivola, superficiale ed esiziale conoscenza della vita, è affidato con buoni risultati a una donna: Marianella Bargilli. L’interprete produce spontaneo divertimento con la sua voce roca, talora tremula o acuta, ma indugia talvolta in una proliferazione eccessiva di smorfie abnormi, dall’affettato intento grottesco (mal consigliata dal regista?).
Senza acuti le prove di Valeria Contadino (Gwendolen) e Giordana Morandini (Cecily). Più riuscita (ma pesa anche il maggiore spessore del personaggio) l’interpretazione di Lady Bracknell da parte di Lucia Poli, che dà all’aristocrazia conformista e buzzurra dell’Impero Vittoriano un ruolo egemone nel dipanarsi della storia, come è tipico di buona parte delle opere del drammaturgo inglese. È con lei che Wilde si lancia in un ambiguo e provocatorio peana all’ignoranza, non senza un sarcastico retroterra politico, che rende possibile all’autore attaccare tanto la bassezza degli altolocati del suo tempo quanto quella dei moralisti che li bacchettano. «Sono molto contraria a tutto ciò che può interferire con una naturale ignoranza» afferma Bracknell. «Le teorie educative del giorno d’oggi sono fondamentalmente assurde. In Inghilterra, comunque – grazie a Dio – l’educazione non produce il minimo effetto. Se non fosse così, ne deriverebbero gravi inconvenienti per le classi superiori, destinati, probabilmente, a sfociare in atti di violenza a Grosvenor Square».
Con questa e altre perle, la gran dama si guadagna il beffardo giudizio dall’impertinente Algie: «È un mostro senza essere un mito; il che, senza dubbio, è sleale». Algernon disprezza in effetti, a sua volta, l’aristocrazia di cui è parte. A disgustarlo sono le visioni scontate e bigotte sulla vita: egli è orientato – parole di Gwendolen – «alla più rigida immoralità». Non per questo accetta, incarnando ancora lo stile libertino di Wilde, di ricadere nell’empatia per gli oppressi propria del coevo maledettismo francese; commenta anzi così, con ironia sociale a dir poco sferzante, il limitato orizzonte della concezione del matrimonio del suo maggiordomo: «Se gli strati inferiori della società non ci danno neanche il buon esempio, si può sapere a che cosa servono?».
Il mondo luccicante e inutile di Wilde resterà sempre, anche solo per due ore, un rifugio gratificante per chiunque sia uso rivolgere uno sguardo divertito a un mondo tanto serioso e pesante quanto esausto nel negare a tutti i costi di esserlo (quello di oggi, s’intende). Un mondo per tromboni e trombonesse travestiti da progressisti, che ci danno noie e ci procurano dolori ogni giorno; dove tutto ciò che pertiene alla sfera erotica deve essere sacrificato sull’altare di un romanticismo di facciata, orientato alla coppia fac-simile del matrimonio quale inconfessabile antidoto alla verace e sorridente disponibilità al piacere e all’avventura esistenziale. Per Algie nulla è peggio di una coppia di sposi che civetta davanti a qualcuno: secondo una geniale espressione del primo atto, ciò equivale «a lavare i propri panni puliti in pubblico». Puliti! Lo aveva chiarito poco prima: «Non c’è niente di romantico in una domanda di matrimonio. Essere innamorati è molto romantico, ma non una precisa proposta matrimoniale (…). L’essenza di ogni storia d’amore è l’incertezza». Sospensione, poi il tipico calo di tensione addolcisce la prosa nervosa, quasi novecentesca: «Se mai mi accadrà di sposarmi, cercherò subito di dimenticarlo».